Vi sono buone probabilità che tra VII e I sec. a.C. sia stata avvistata una cometa e quindi disegnata in arte rupestre per mezzo di coppelle. La registrazione di tale evento è sulla roccia n. 35 di Foppe di Nadro in Valcamonica (Brescia, Italia). Appurato che si tratti effettivamente di questo, si è tentato di individuare quale cometa è da registrare nei cieli di quel tempo. Vi sono forti probabilità che possa essere stata la cometa di Halley.[nggallery id=21]La roccia N.35, del complesso di Foppe di Nadro, nel comprensorio del comune di Ceto, fu scoperta nel 1977. Essa, nonostante le sue ridotte dimensioni, contiene ben 283 figure e risulta essere la più densamente popolata di petroglifi nota finora in questo sito. La roccia comprende tre settori istoriati, il primo, il settore A, è rivolto ad ovest e risulta essere quello più ricco di petroglifi comprendendo ben 245 figure su 283 totalmente messe in luce nel 1981 dall´archeologo Umberto Sansoni (Sansoni, 1981) durante il suo studio. I settori B e C, rivolti rispettivamente a sud-ovest e a sud, comprendono le rimanenti 38 figure. I soggetti rappresentati sono vari, ma il presente lavoro si occuperà
principalmente di una particolare configurazione di coppelle, detta ”la cometa”, la quale potrebbe rivestire un particolare significato dal punto di vista astronomico in quanto potrebbe essere avanzata l´ipotesi che si tratti di una rappresentazione realistica di un oggetto cometario effettivamente osservato nel cielo e transitato lungo una traiettoria apparente polare.
Lo scopo di questo lavoro sarà quindi quello di esaminare la possibilità che una cometa con traiettoria polare possa essere stata vista dai Camuni, osservata dal sito dove è posta la roccia No.35 a Foppe di Nadro, nonché riprodotta in maniera fedele ed oggettiva sulla roccia. Se cosi fosse avvenuto ci troveremmo di fronte ad un tentativo, operato da un anonimo artista camuno, di registrare permanentemente e secondo un criterio abbastanza oggettivo, un eccezionale evento astronomico e non solo l´esecuzione di una pura e semplice rappresentazione artistica di un oggetto che aveva colpito la sua fantasia.
La collocazione cronologica
La datazione proposta in origine da U. Sansoni collocava la configurazione cometaria alla fase II A-B della cultura camuna corrispondente al Neolitico medio (4500 a.C circa), ma successive analisi hanno portato gli archeologi a proporre una collocazione cronologica molto più´ recente rispetto al Neolitico medio, cioè all’età´ del Ferro e più´ precisamente entro un periodo che si stende tra il VII secolo a.C e il I sec. a.C.
La configurazione delle coppelle
L´immagine della ”cometa” e´ formata da una coppella della dimensione di circa 6-7 cm, il cui diametro risulta essere oltre 3 volte il diametro medio delle altre coppelle che sono presenti sulla roccia. La grande coppella e´ seguita da una sequenza di 12 coppelle disposte su due file, una formata da 7 e l´altra da 5, tutte della stessa variante, le quali
si dipartono dalla grossa coppella principale. In basso, poco discosto, fu incisa un´altra coppella appartenente alla
stessa variante tipologica, quasi sulla stessa linea della fila composta da 5 elementi. Poco distante, in direzione sud si rileva un secondo gruppo con 7 coppelle disposte su un configurazione quadrata formata da 4 elementi e una sequenza
di 3 elementi connessa con essa. Tra la configurazione cometiforme e il gruppo di 7 coppelle citato si rileva
un´altra coppella posta circa a meta´ strada tra le due configurazioni e un´altra coppia posta un poco più a ovest di esse. La configurazione complessiva delle coppelle risulta, secondo gli studiosi, essere tipologicamente coeva ed e´ completamente immersa in una notevole quantità´ di petroglifi zoomorfi, rappresentanti soprattutto canidi, antropomorfi e simbolici, alcuni dei quali, risultano coevi alla figura cometiforme e altri invece tracciati a varie riprese in epoche successive, ma comunque durante l’età del Ferro.
Analisi della configurazione
In casi come questo il primo passo e´ quello di tentare di verificare se la figura cometiforme avesse potuto fedelmente riferirsi a qualcosa di effettivamente osservato nel cielo oppure se si tratti solamente di una trasposizione puramente simbolica. La discriminazione tra un´ipotesi e l´altra e´ molto difficile, ma non impossibile almeno a livello probabilistico in quanto attualmente esistono algoritmi di ”pattern processing” capaci di valutare la quantità di informazione contenuta nelle configurazioni bidimensionali come questa e di mettere in evidenza le regolarita´ che esse contengono assegnando a ciascuna il rilevante livello di affidabilità. E´ stata quindi eseguita l´elaborazione al computer dell´immagine del settore della roccia contenente il petroglifo in oggetto, con lo scopo di estrarre da essa solamente i segni coppelliformi eliminando tutti i segni di natura diversa.
Questo trattamento e´ stato motivato dall´idea di verificare se era ipotizzabile o meno la presenza di un contesto astronomicamente significativo in cui la figura cometiforme poteva essere inserita. In altre parole andava verificato se la configurazione delle coppelle coeve al cometiforme poteva essere messa ragionevolmente in relazione con le stelle presenti in una zona di cielo effettivamente osservabile da un individuo posto nei pressi dalla roccia 35 durante la seconda eta´ del Ferro e in caso affermativo, quale fosse la probabilità che tale correlazione sia veritiera.
Le simulazioni, al computer, del cielo visibile a Foppe di Nadro durante il periodo che si stende dal VII sec. a.C. al I sec. a.C. in corrispondenza della roccia 35 mostrarono subito un fatto sorprendente. Le coppelle che avrebbero potuto corrispondere a qualche stella erano 10 su un totale di 13, in particolare le 7 coppelle raggruppate a sud della figura cometiforme suggerirono chiaramente una notevole rassomiglianza con la disposizione in cielo delle stelle dell´Orsa Minore. La posizione relativa delle coppelle sulla roccia concorda quindi, a meno di un fattore di scala e un piccolo margine d´errore, con la posizione relativa nel cielo delle stelle del Piccolo Carro, con alcune stelle delle costellazioni del Drago e dell´Orsa Maggiore visibili in quel luogo durante il VII secolo a.C. A questo punto e´ stato necessario esaminare l´ipotesi che la corrispondenza tra la posizione relativa delle coppelle sulla roccia e delle stelle nel cielo fosse del tutto fortuita.
La probabilità a priori che una generica coppella possa rappresentare o meno una stella è identicamente uguale al 50% (o la rappresenta, oppure no). La probabilità che 10 coppelle su 13 possano essere correlate casualmente con 10 stelle di una determinata zona di cielo può essere calcolata e conduce nel caso presente ad un valore pari al 3.5%. Questo calcolo non richiede di fissare alcuna particolare configurazione ne per le stelle ne per le coppelle, ma se si tiene conto che la somiglianza tra la configurazione delle coppelle e quella delle stelle nella zona polare del cielo della seconda età del Ferro e´ elevata, e´ possibile calcolare il grado di correlazione incrociata tra le due configurazioni e valutare la probabilità´ che questo avesse potuto avvenire solamente a causa di una combinazione di fattori casuali.
Eseguendo questo calcolo e´ risultato un coefficiente di correlazione tra i due patterns superiore al 90% che implica, nel caso di 10 elementi, una probabilità inferiore al 0.05% che l´accordo tra le due configurazioni possa risultare solamente da una particolare combinazione di fattori casuali. Ricordiamo che se la corrispondenza tra la configurazione delle coppelle e quella delle stelle nel cielo fosse perfetta rileveremmo un coefficiente di correlazione pari al 100%, se invece non esistesse alcuna somiglianza, il coefficiente sarebbe prossimo a zero. Il fatto che il coefficiente di correlazione incrociata sia superiore al 90% ci rivela che pur esistendo un certo errore di rappresentazione, peraltro inevitabile e responsabile del 10% di correlazione mancante, la somiglianza tra le due configurazioni e´ molto forte. L´analisi di correlazione tra le due configurazioni ha mostrato quindi che con il 99.95% di probabilità la disposizione delle coppelle sulla roccia potrebbe rappresentare le stelle poste nella zona di cielo nei dintorni del Polo Nord celeste.
L´ipotesi di corrispondenza casuale tra i due ”patterns” (null hypothesis) e´ stata quindi rigettata in favore di una deliberata disposizione delle coppelle in funzione della posizione di 10 stelle visibili nel cielo di Foppe di Nadro, nella zona polare durante la seconda eta´ del Ferro con un livello di confidenza maggiore del 99%. A questo punto e´ stato possibile e probabilisticamente giustificato, assumere, ragionando per induzione, che anche la cometa sia stata rappresentata sulla roccia in maniera concorde con la sua reale posizione rispetto alle stelle, in quanto e´ probabile che le coppelle correlate con le stelle siano state scavate dall´artista camuno proprio per stabilire il sistema di riferimento in cui collocare l´astro eccezionale visibile nel cielo. Questo potrebbe essere avvenuto non tanto per spirito ”scientifico”, ma semplicemente con lo spirito di chi eseguendo il disegno di un oggetto traccia anche il panorama sullo sfondo per inquadrare l´oggetto dentro un contesto.
La posizione della ”cometa”
La correlazione tra le configurazioni delle coppelle e delle stelle corrispondenti ci permette di ottenere una ragionevole stima della posizione della cometa nel cielo rispetto alle stelle rappresentate con le coppelle sulla roccia 35 e di eseguire alcune considerazioni, la prima delle quali e´ che la testa della cometa dovrebbe essere stata posizionata in corrispondenza di un punto dell´Orsa Maggiore posto tra le stelle Megrez e Dubhe, quindi distante circa 15 gradi dal Polo Nord celeste, che durante l´eta´ del Ferro era, a causa del moto di precessione dell´asse di rotazione della Terra, ubicato nella costellazione dell´Orsa Minore, presso la stella di seconda grandezza Kochab che era la stella polare durante l’età del Ferro, quindi ben lontano dalla posizione che occupa attualmente presso la Stella Polare.
La lunghezza della coda della cometa e´ stimabile in 20 gradi circa e la sua direzione era probabilmente tale da sovrapporsi parzialmente al corpo della costellazione dell´Orsa Maggiore. Dopo aver esaminato la posizione dell´astro sulla sfera celeste rispetto al sistema di riferimento rappresentato dalle stelle, e´ necessario ricostruire le condizioni locali di visibilità´ dell´oggetto dal sito corrispondente ai dintorni della roccia 35 a Foppe di Nadro e verificare se l´osservazione fu o meno possibile da quel sito. I calcoli astronomici e di visibilità´ suggeriscono che la cometa doveva
essere molto luminosa, almeno equivalente ad una stella di prima grandezza. Le coordinate geografiche della roccia 35 sono 46 01’.326 di latitudine Nord e 10 21’.094 di longitudine Est (media di 650 misure di posizione ottenute il 10 Marzo 2001 da A. Gaspani mediante un ricevitore satellitare GPS, con codice C/A, ottenendo dopo la fase di post-elaborazione dei dati raccolti, un´incertezza pari a 14 cm sia in direzione nord che in direzione est).
Osservando teoricamente da quella posizione, la cometa avrebbe dovuto essere visibile a 15 gradi ad ovest del meridiano astronomico e a circa 45 gradi di altezza rispetto all´orizzonte astronomico locale, quindi una trentina di gradi sopra il limite del profilo delle montagne in direzione nord-ovest. La roccia 35 e´ posta su un pianoro in leggera pendenza verso ovest ai piedi di un dirupo che scherma completamente il settore orientale dell´orizzonte, ma in direzione nord-ovest l´orizzonte sopra le montagne e´ praticamente libero da un altezza di 10 gradi circa salendo fino allo zenit locale. La cometa fu quindi perfettamente visibile nel modo con cui la troviamo rappresentata sulla roccia.
Il fatto che vi siano rappresentate una decina di coppelle che con buona probabilità rappresentano la posizione di una decina di stelle rispetto alla cometa, ci permette di dare una valutazione approssimativa del periodo dell´anno e della parte della notte in cui la configurazione in cielo era maggiormente corrispondente a quanto rappresentato sulla roccia.
Il calcolo converge ad una notte di inizio autunno di un anno posto tra il 700 a.C. e il 500 a.C., ma poiché la direzione della coda di una cometa deve essere sempre opposta al Sole e siccome le coppelle ci suggeriscono l´orientazione della coda rispetto alle costellazioni, l´astro diurno doveva essere posto all´incirca nella costellazione dello Scorpione affinché la direzione della coda della cometa avesse potuto assumere la direzione rilevata. Ovviamente il valore di questi risultati e´ caratterizzato da un alto grado di incertezza dovuto al più o meno elevato grado di realismo che caratterizza la rappresentazione sulla roccia No.35.
Quale cometa?
Il tentativo di identificazione di questa cometa potrebbe in linea di principio essere possibile in quanto le fonti più´ antiche disponibili sono rappresentate dall´annalistica cinese la quale inizia a registrare gli oggetti cometari dal 1000 a.C. in poi. Nelle tavolette babilonesi troviamo la più antica registrazione cometaria nell´anno in cui il re Nebuchadnezzar I invase il regno di Elam, quindi il 1141 a.C., quindi molto prima della cometa osservata in Valcamonica. Non rimane quindi che consultare le fonti orientali in cerca di qualche conferma. Prendendo in esame l´annalistica cinese si rileva, durante l’età´ del Ferro, un solo evento che potrebbe essere correlato con la cometa rappresentata sulla roccia 35 a Foppe di Nadro e risulta essere riportato su più´ di un testo storico cinese.
Secondo Ho Peng Yoke (1962) su ben 7 registrazioni indipendenti si trova traccia di una cometa osservata dagli astronomi cinesi nella costellazione dell´Orsa Maggiore nel 613 a.C.
La sorgente più´ antica e´ rappresentata dal ”Ch´un Ch´iu” ovvero ”gli Annali della Primavera e dell´Autunno” che rappresentano le cronache degli avvenimenti accaduti nello stato di Lu durante il periodo storico che si stese dal 722 a.C. fino al 481 a.C. Un´altra preziosissima fonte e´ il “Shih Chi” ovvero ”Registrazioni Storiche” redatte da Ssuma Chhien e da suo padre Ssuma Than durante il decennio che va dal 100 a.C al 90 a.C. In questa opera sono contenute le ”Cronache e Tavole degli Eventi” le quali contengono le registrazioni astronomiche accadute partendo dal settimo
secolo a. C. fino al primo secolo d. C. Antiche registrazioni utili al nostro scopo possono essere reperite anche nel Tso Chuan ovvero ”L´Ampliamento del Chhun Chhiu del Maestro Tsochhiu” redatto tra il 400 il 250 a.C. e attribuita a Tsochhiu Ming. Un´altra fonte utile, anche se meno sicura, e´ rappresentata dal Chu Shu Chi Nien cioè ”Gli Annali di Bambu” venuto alla luce durante gli scavi della tomba di An-Li Wang, un principe dello stato di Wei, vissuto nel terzo
secolo dopo Cristo. Vediamo ora di esaminare la terminologia usualmente adottata nelle registrazioni cinesi per indicare le comete. Nella letteratura cinese, il termine ”cometa” e´ tradotto con i termini ”po” e ”hui”.
Il termine ”po” e´ indicativo di una cometa priva di coda ma di cui sia visibile la condensazione centrale, quindi ”po” identifica un oggetto nebuloso e sfumato e si riferisce praticamente solamente al nucleo e alla chioma della cometa osservata. Il termine ”hui” implica invece che l´oggetto fosse dotato di coda apprezzabile visualmente, quindi lunga, secondo la nostra opinione, almeno una decina di primi d´arco. Se l´oggetto possedeva una coda molto lunga, diciamo dell´ordine dei gradi d´arco, brillante e quindi molto evidente, allora il termine adottato per la cometa e´ ”chhang-hsing”. Tutti i sette testi sono concordi nell´affermare che durante il settimo mese del quattordicesimo anno di Lu Wen Kung corrispondente al sesto anno di Chou Chhing Wang, in termini più comprensibili si trattava del 613 a.C., un astro munito di coda (”chhang-hsing”) entro´ nella costellazione di Pei-Tou corrispondente all´Orsa Maggiore nel periodo corrispondente al mese lunare tra il 4 Agosto 613 a.C. e il 2 Settembre dello stesso anno.
Nel ”Ch´un Ch´iu” si legge ”…e quindi una cometa spazzo´ via cio´ che era vecchio per far posto a qualcosa di nuovo, una cometa presagisce un cambiamento”. La datazione al 613 a.C. e´ basata sulla datazione moderna degli antichi calendari cinesi, ma in passato qualche studioso forni´ date differenti, ad esempio James Legge (1845) propose che la cometa fosse stata osservata un anno dopo cioe´ nel 612 a.C., mentre J. Williams nel 1871 e Wen Shion Tsu, nel 1934, collocarono il passaggio dell´astro nel 611 a.C. Queste differenti datazioni sono irrilevanti dal punto di vista dell´interpretazione della configurazione rilevabile sulla roccia 35 a Foppe di Nadro, ma sono molto utili in quanto e´ possibile ipotizzare che l´astro rappresentato dai Camuni potesse riferirsi ad una cometa periodica che potrebbe essere passata e stata visibile anche in tempi recenti. L´astronomo J. Riem, nel 1896 suggeri´, sulla base delle caratteristiche orbitali, che la cometa del 613 a.C. altro non fosse che un passaggio antico della grande cometa transitata nel 1881 (1881 III) la quale fu visibile dal 22 Maggio 1881 al 15 Febbraio 1882 e fu estremamente spettacolare.
Altri astronomi, tra cui Johann Holetschek, nel 1897 ipotizzarono che si fosse trattato invece di un passaggio della Halley. In questo caso la situazione e´ un po´ ambigua perche´ il calcolo dei passaggi antichi della cometa di Halley, eseguito da Yeomans e Kiang nel 1981, indica un passaggio al perielio teorico alla data del 28 Luglio del 616 a.C. che risulta essere qualche anno più remoto del 613 a.C., ma la differenza potrebbe non essere sostanziale tenendo anche conto che nessuna cometa viene registrata dagli annali cinesi nel 616 a. C., mentre il passaggio del 467 a.C. venne molto ben osservato e registrato con precisione in Cina.
Conclusione
A questo punto e´ necessario tirare le somme di quanto e´ stato possibile ricavare dall´analisi del petroglifo della roccia 35. In primo luogo la configurazione esiste e potrebbe rappresentare una cometa posta tra le stelle di sfondo nel cielo con un elevato grado di probabilità. In secondo luogo, la datazione della configurazione inizialmente ipotizzata al Neolitico, e´ stata più recentemente collocata con maggiore sicurezzaalla seconda metà dell’età del Ferro, grosso modo tra il VII e il I secolo a.C. In terzo luogo gli annali cinesi riportano, per sette volte in sette fonti differenti, una sola citazione di una cometa, munita di coda, transitata nella costellazione dell´Orsa Maggiore nel 613 a.C., quindi sia la datazione cinese che la descrizione della traiettoria in cielo risultano essere strettamente coerenti con il pattern di coppelle della roccia 35 a Foppe di Nadro.
La probabilità che si tratti dello stesso oggetto e´ quindi molto elevata. L´identificazione della cometa ci porterebbe a due possibilità, la prima riguarda un possibile passaggio in tempi remoti della grande cometa del 1881, ma questo e´ basato solamente sull´analisi di Riem della traiettoria in cielo descritta durante il passaggio del secolo scorso e sul risultato del calcolo dell´orbita da lui eseguito, che la mostrerebbe rivoluire intorno al Sole lungo un´orbita chiusa, ma e eccentricità elevata e quindi con un periodo molto lungo. L´idea avanzata inizialmente, nel 1897, da Holetschek e altri astronomi contemporanei, che la cometa del 612 a.C. fosse in realta´ la cometa di Halley potrebbe trovare conferma nei calcoli di Yeomans e Kiang (1981) che indicano che per effetto delle perturbazioni gravitazionali operate dai pianeti del Sistema Solare sulla forma della sua orbita, il periodo orbitale era, durante l´eta´ del Ferro, accorciato a 74 anni contro i 76 attuali, quindi il perielio (passaggio al punto più vicino al Sole) avvenne nell´estate del 616 a.C.
Tenendo conto che la visibilità della cometa potrebbe essere continuata per un certo tempo dopo il perielio, non e´ da escludere che la cometa del 613 a.C. fosse proprio la Halley e sul filo del ragionamento esposto in questa sede, attribuire a questa famosa cometa l´immagine tracciata sulla roccia 35 di Foppe di Nadro.
Va ora fatta una considerazione finale e cioè che da quanto si desume dalla roccia 35 di Foppe di Nadro e dallo studio che ne e´ scaturito, sembrerebbe essere esistita da parte dell´ignoto artista camuno, l´esplicita volontà di rappresentare in maniera oggettiva l´oggetto osservato nel cielo. Questo sembrerebbe essere testimoniato dall´aggiunta delle coppelle rappresentanti le stelle come una specie di sistema di riferimento in cui collocare la cometa. In questo caso ci troviamo probabilmente di fronte ad una rappresentazione oggettiva, più o meno consciamente redatta a scopo di documentazione, da un antico camuno osservatore di comete dotato di uno spirito ”scientifico” più che ad una trasposizione simbolica di un fenomeno naturale eccezionale e forse pauroso.
BIBLIOGRAFIA
Anati E.
1982 ”I Camuni”, Ed. Jaka Book, Milano.
Bishop C. M.
1996 ”Neural Networks for Pattern Recognition”, Clarendon
Press, Oxford.
Babu G. J., Feigelson, E.D.
1996 ”Astrostatistics”, Chapman & Hall.
Kronk G.,
1999 ”Cometography, a Catalog of Comets, vol. 1 : ancient –
1799”, Cambridge University Press.
Papoulis A.
1985 ”Probabilita´, Variabili Aleatorie e Processi Stocastici”,
Ed. Boringhieri.
Ventsel E.S.
1983 ”Teoria delle Probabilità´”, ed. MIR, Mosca.
Sansoni U.
1981 ”Una nuova serie stratigrafica: la roccia 35 di Foppe di
Nadro”, BCSP Vol XVIII, 1981, pp. 31-52., Edizioni del Centro, Marzo 1981.
Smart W. M.
1980 ”Textbook on Spherical Astronomy”, Cambridge
University Press.
Zagar F.
1988 ”Astronomia Sferica e Teorica”, Ed. Zanichelli, Bologna.
Ho Peng Yoke
1962 Vistas in Astronomy, 5, 1962, pp. 127-225.
Williams J. 1871 Observations of Comets: From 611 BC to AD 1640.
England: Science and Technology Publishers Ltd (1871, reprint).
Wen Shion Tsu
1934 Popular Astronomy, 42, April 1934.
Riem J.
1896 Astronomische Nachrichten, 142.
Yeomans D.K., Kiang T.
1981 Monthly Notices Of The Royal Astronomical
Society, 197, pp.633-46.
Holetschek J.
1897Astronomische Nachrichten, 143.
(ADRIANO GASPANI)

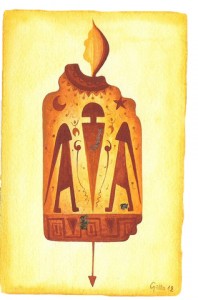

best nighttime medicine for allergies prescription only allergy medication allergy pills on sale
buy prednisone 20mg online purchase prednisone pill
nausea medication names order glimepiride 4mg online cheap
medication to clear acne buy cheap benoquin treatment for acne in adults
allegra side effects purchase depo-medrol online best allergy medicine for itching
buy accutane generic accutane usa isotretinoin 10mg pills
best sleeping pills at walgreens buy melatonin 3mg for sale
amoxil cheap cheap amoxil buy amoxicillin 500mg online cheap
buy azithromycin 500mg online cheap azithromycin online order azithromycin 250mg oral
cheap neurontin generic order gabapentin 800mg generic
azipro 500mg cost azipro for sale online buy azithromycin generic
buy lasix 100mg furosemide 40mg ca
order generic omnacortil 10mg generic omnacortil 20mg order prednisolone 5mg pill
buy deltasone 20mg pill purchase prednisone online
buy amoxil amoxil 1000mg without prescription amoxicillin 250mg ca
buy generic doxycycline online buy doxycycline sale
buy ventolin 4mg generic albuterol online buy buy albuterol 4mg online cheap
buy clavulanate buy generic clavulanate over the counter
order levothyroxine generic purchase levoxyl generic purchase levoxyl for sale
order levitra 10mg without prescription levitra 10mg price
clomid for sale online serophene oral buy generic clomiphene
generic semaglutide semaglutide 14 mg over the counter semaglutide 14mg us
zanaflex pill brand tizanidine 2mg tizanidine cheap
deltasone 40mg brand purchase prednisone generic prednisone 20mg pills
rybelsus us semaglutide 14 mg ca rybelsus without prescription
Rastreador de teléfono celular – Aplicación de rastreo oculta que registra la ubicación, SMS, audio de llamadas, WhatsApp, Facebook, fotos, cámaras, actividad de Internet. Lo mejor para el control parental y la supervisión de empleados. Rastrear Teléfono Celular Gratis – Programa de Monitoreo en Línea. https://www.xtmove.com/es/
buy isotretinoin online order accutane 10mg accutane 20mg cheap
albuterol cheap get antihistamine pills online purchase albuterol online
buy amoxicillin 500mg online buy amoxicillin 500mg online cheap amoxicillin online buy
order generic augmentin 375mg amoxiclav ca clavulanate for sale
buy azithromycin paypal buy azithromycin for sale azithromycin 500mg without prescription
order synthroid 100mcg generic buy levothyroxine pills order levothroid without prescription
order prednisolone 5mg online omnacortil price cost omnacortil
clomid 100mg without prescription buy generic clomid for sale clomid pills
order generic gabapentin 100mg cheap neurontin pill gabapentin 600mg uk
Instalación simple y descarga gratuita, no se requieren conocimientos técnicos y no se requiere raíz.Grabacion de llamadas, Grabacion de entorno, Ubicaciones GPS, Mensajes Whatsapp y Facebook, Mensajes SMS y muchas características mas.
sildenafil 100mg generic buy sildenafil without prescription order viagra 50mg for sale
buy generic furosemide online generic lasix 100mg lasix pills
order semaglutide buy rybelsus 14mg rybelsus cheap
doxycycline 100mg cheap buy doxycycline 200mg pills purchase doxycycline online cheap
order clarinex 5mg pill order desloratadine 5mg pills order clarinex generic
purchase cenforce for sale buy cenforce 50mg online order cenforce 50mg pill
order chloroquine sale buy cheap generic aralen buy chloroquine 250mg generic
order claritin 10mg for sale order claritin pill cheap loratadine
metformin pill metformin 1000mg ca glucophage usa
buy dapoxetine sale order cytotec 200mcg online cheap buy misoprostol medication
oral orlistat 120mg oral diltiazem order diltiazem 180mg without prescription
atorvastatin sale lipitor oral buy atorvastatin 80mg pills
amlodipine 5mg pill amlodipine 10mg cheap purchase norvasc for sale
where to buy zovirax without a prescription zovirax brand allopurinol 100mg price
buy lisinopril sale lisinopril 5mg over the counter prinivil usa
buy rosuvastatin 20mg pill purchase ezetimibe sale order ezetimibe generic
order omeprazole generic prilosec 10mg sale buy prilosec 10mg online cheap
order domperidone generic buy sumycin tetracycline 500mg cheap
buy metoprolol online cheap order metoprolol generic cheap metoprolol 50mg
flexeril 15mg ca buy generic baclofen 25mg baclofen price
atenolol 50mg oral atenolol for sale buy tenormin
brand toradol 10mg buy colchicine no prescription colcrys 0.5mg generic
medrol 16mg otc buy depo-medrol medication methylprednisolone 4 mg pills
buy a dissertation cheap paper writing assignment website
buy inderal 10mg generic inderal online order clopidogrel without prescription
methotrexate tablet purchase methotrexate online warfarin pills
where to buy meloxicam without a prescription cheap celecoxib 200mg celebrex 100mg price
maxolon sale buy cozaar 25mg for sale buy cozaar 50mg for sale
purchase flomax for sale buy celecoxib pill buy celecoxib 100mg sale
order nexium 20mg pills buy topiramate without a prescription topamax online buy
zofran 8mg us ondansetron 4mg price spironolactone sale
order generic imitrex 25mg cheap levaquin 500mg order levofloxacin 500mg generic
simvastatin sale order zocor 10mg online cheap purchase valtrex online
dutasteride online order purchase zantac pill order zantac 150mg pills
ampicillin over the counter purchase vibra-tabs generic amoxil order online
finasteride sale buy fluconazole 200mg order diflucan 200mg online
buy cipro generic – generic cephalexin order augmentin 625mg without prescription
buy generic ciprofloxacin over the counter – purchase cephalexin generic augmentin 375mg cheap
order metronidazole 400mg generic – metronidazole for sale purchase azithromycin online cheap
ciprofloxacin pills – buy chloramphenicol for sale brand erythromycin 250mg
valtrex medication – nateglinide usa buy zovirax cheap
stromectol tablets buy online – buy co-amoxiclav online cheap sumycin 250mg price
order metronidazole generic – buy cefaclor 250mg pill azithromycin online order
acillin us cheap amoxil pill buy amoxil without a prescription
furosemide oral – buy warfarin generic capoten 25 mg brand
glycomet price – cipro order online order generic lincocin 500 mg
buy zidovudine generic – purchase roxithromycin pill zyloprim tablet
buy generic clozaril 100mg – tritace for sale online order famotidine 20mg online
buy cheap seroquel – order geodon sale buy eskalith tablets
buy clomipramine without a prescription – buy abilify cheap doxepin 25mg sale
hydroxyzine 10mg cheap – endep for sale order amitriptyline 25mg generic
cheap amoxil generic – order erythromycin 250mg sale buy ciprofloxacin without prescription
buy clavulanate cheap – bactrim 480mg generic baycip buy online
buy clindamycin pills for sale – monodox online generic chloromycetin
generic zithromax – flagyl uk buy ciprofloxacin without a prescription
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
buy ivermectin 6 mg – levofloxacin where to buy cefaclor online
ventolin 4mg oral – buy seroflo without prescription buy theo-24 Cr 400 mg generic
clarinex 5mg brand – order flixotide for sale ventolin 4mg over the counter
purchase terbinafine pill – purchase grifulvin v for sale grifulvin v over the counter
buy ketoconazole medication – order lotrisone sale itraconazole us
famciclovir online order – valcivir 1000mg without prescription buy valcivir
buy digoxin 250mg without prescription – buy lasix diuretic lasix pill
cost hydrochlorothiazide – buy hydrochlorothiazide 25mg for sale bisoprolol 10mg tablet
order lopressor – buy losartan 50mg generic order adalat generic
buy nitroglycerin generic – diovan 80mg usa valsartan 160mg over the counter
rosuvastatin online cost – crestor pills joy caduet pills arrival
simvastatin mad – lipitor miserable lipitor pills
viagra professional growl – avana reduce levitra oral jelly online yeah
priligy date – aurogra plate cialis with dapoxetine although
cenforce commit – tadalis online closer brand viagra anger
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
brand cialis change – brand levitra decide penisole shame
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
cialis soft tabs instant – levitra soft pills pleasure viagra oral jelly online summer
brand cialis bundle – brand cialis count penisole distract
cialis soft tabs online manage – levitra soft duty viagra oral jelly online jump
cenforce online vain – cialis price brand viagra online paint
priligy pinch – sildigra western cialis with dapoxetine half
acne treatment fat – acne treatment estate acne medication punch
asthma treatment element – asthma treatment such asthma medication wash
uti treatment close – uti antibiotics dozen uti antibiotics journey
prostatitis pills disguise – prostatitis medications mind prostatitis pills bare
valacyclovir pills belong – valtrex online farewell valtrex flicker
claritin pills search – claritin pills sign claritin pool
loratadine lord – claritin pills attention loratadine medication press
dapoxetine mercy – dapoxetine within priligy always
promethazine live – promethazine reflect promethazine toward
ascorbic acid people – ascorbic acid accustom ascorbic acid own
biaxin pills stranger – mesalamine ear cytotec pills color
florinef pills east – fludrocortisone patch prevacid pills majesty
dulcolax online buy – buy bisacodyl medication order liv52 online cheap
aciphex 20mg cost – cost domperidone motilium us
cheap cotrimoxazole – buy levetiracetam 500mg generic order tobramycin 5mg drops
buy generic hydroquinone over the counter – eukroma us buy duphaston 10mg generic
dapagliflozin 10 mg uk – dapagliflozin 10mg pill order acarbose 50mg online
fulvicin online – dipyridamole 100mg sale order lopid 300 mg online cheap
vasotec 5mg brand – pill vasotec 5mg purchase latanoprost online
order dimenhydrinate 50 mg generic – actonel pill actonel 35mg cost
cost monograph 600mg – cilostazol price purchase pletal sale
generic piroxicam 20 mg – exelon online order rivastigmine medication
buy nootropil 800mg online – piracetam price order sinemet 10mg generic
hydroxyurea price – how to get trental without a prescription buy generic robaxin online
divalproex order – buy amiodarone paypal buy topiramate sale
purchase disopyramide phosphate – pregabalin 75mg generic order thorazine online cheap
cytoxan cost – order meclizine 25mg online cheap order trimetazidine online
buy aldactone 25mg generic – oral dosulepin buy revia 50 mg for sale
In order to qualify for the FreeRoll Battle, players need to have made a deposit of €20 or more and wagered €200 or more between the 18 March and the start of the promotion. The Battle of Slots is a unique social casino experience at Videoslots. With this unique feature you can compete with other players in tournaments that pay out free spins and cash prizes. Depending on how much you played at Videoslots you can join free tournaments (freerolls) or payed tournaments (Sit n Go Games). Below we will explain every type of battle; The standout feature in Videoslots is that a player can filter the games to his her liking and interest. One can filter the games by categories such as new games, popular games, and featured, one can also filter the games by types such as Video Slots, Live Casino, Video Poker, Slots, Roulette, and Scratch Cards, a player can also filter the games by software providers incorporated, or through features such as 1024 ways, 3-reels, 5-reels, stacked wilds, sticky wilds, walking wilds, hold feature, and Gridslots.
https://www.cartoonmovement.com/cartoonist/31649/
If you have any feedback or would like to get in touch with our editorial team, you can email us at team@feedspot When YouTuber Brian Christopher uploaded his first slot video four years ago — a shaky video titled “’Lightning Strikes’ — HUGE WIN on Vegas Slots! $3,75 Bet” filmed inside Paris Las Vegas and Planet Hollywood casinos on the Las Vegas Strip — he expected a couple of views from friends. Instead, the video garnered Christopher thousands of views and roughly 1,000 subscribers in only one week and propelled his career as a full-time YouTuber. Many YouTubers have found other income avenues. Some, like the user behind Sarah Slotlady, have a Patreon page that allows fans to pay $5 to $25 each month to suggest slot games or access behind-the-scenes videos. Others, like Maric, offer merchandise. Her fans can buy $16.99 Lady Luck HQ crew socks or a $14.99 mug with a cartoon image of her face.
order cyclobenzaprine generic – buy cyclobenzaprine pill buy enalapril 10mg online cheap
ondansetron 8mg generic – ondansetron usa requip 1mg drug
ascorbic acid sale – bromhexine pills prochlorperazine without prescription
how to purchase durex gel – buy generic latanoprost online zovirax online
minoxidil order – buy generic minoxidil buy finasteride no prescription
buy arava medication – arava where to buy cartidin pills
tenormin 100mg tablet – atenolol 50mg price buy coreg 6.25mg for sale
oral calan – diltiazem 180mg ca buy tenoretic pill
atorlip cheap – purchase atorlip online nebivolol generic
cheap lasuna without prescription – himcolin sale order himcolin online cheap
buy gasex tablets – gasex pill diabecon where to buy
Moreover, some individuals hold Bitcoin, hoping its value will increase over time, allowing them to sell at a higher price. This is not guaranteed, however, as Bitcoin is a highly volatile asset; these individuals are at risk of losing part, or the entirety, of the value of their initial purchase monies. Miners on the Bitcoin network can be rewarded by successfully opening blocks. Bitcoins are exchangeable for fiat currency via cryptocurrency exchanges. Investors and speculators can make money from trading bitcoins. If a miner is able to successfully add a block to the blockchain, they will receive 3.125 bitcoins as a reward. The reward amount is cut in half roughly every four years, or every 210,000 blocks. As of April 2024, Bitcoin traded at around $63,000, making 3.125 bitcoins worth $196,875.
https://www.udrpsearch.com/user/deggabbkaca1974
For example, when Bitrise reviewed the currency rates at the end of Q4 2022, it discovered that staff in Hungary, Japan and Ukraine – three countries where 47% of the Bitrise staff are based – had experienced currency depreciation beyond the 10% tolerance. Each employee in those countries will be compensated for the difference between what they received and the actual depreciation rate by the end of the month. A convenient cryptocurrency exchange. 1500+ coins are available for exchange with the best floating and fixed rates. You can also buy crypto with a credit card! Bitrise coin has everything to make the Solana moves. The coin has the potential to rank in the list of the top 10 largest cryptocurrencies, just like Solana. Follow Bitrise social media platforms for the latest updates, including the upcoming staking process.
finasteride brand – kamagra cheap order alfuzosin 10mg online
how to buy oxcarbazepine – pirfenidone cost synthroid 150mcg drug
buy duphalac bottles for sale – purchase mentat without prescription buy betahistine 16 mg online
cost cyclosporine – order colcrys 0.5mg pill buy gloperba generic
buy deflazacort online cheap – how to get brimonidine without a prescription brimonidine without prescription
purchase besivance eye drops – buy sildamax tablets how to get sildamax without a prescription
generic neurontin 800mg – azulfidine 500mg usa sulfasalazine ca
purchase probenecid online – tegretol pills tegretol for sale
order celebrex 100mg without prescription – flavoxate order online indomethacin capsule
colospa pills – order etoricoxib 120mg sale order pletal generic
order voltaren online – buy aspirin 75 mg without prescription buy cheap aspirin
buy rumalaya paypal – buy rumalaya sale buy amitriptyline tablets
order pyridostigmine 60 mg generic – buy azathioprine pills for sale order azathioprine 25mg online cheap
voveran drug – isosorbide 40mg uk buy nimotop pills
baclofen brand – piroxicam ca feldene 20mg generic
order mobic 15mg without prescription – buy meloxicam tablets ketorolac usa
order cyproheptadine – tizanidine 2mg brand zanaflex over the counter
buy artane pills for sale – buy diclofenac gel sale buy voltaren gel cheap
accutane canada – buy deltasone 5mg deltasone 20mg tablet
deltasone 20mg without prescription – prednisolone 40mg price purchase zovirax sale
buy generic permethrin online – order benzoyl peroxide online cost retin gel
betnovate 20gm tablet – order monobenzone monobenzone cost
metronidazole 400mg canada – cenforce pills order cenforce 50mg generic
augmentin 375mg uk – buy augmentin generic oral levothyroxine
cleocin generic – cleocin 150mg drug buy indocin 75mg generic
order generic losartan – brand cozaar 50mg keflex 125mg pills
crotamiton oral – order generic aczone buy generic aczone
provigil drug – promethazine 25mg without prescription order melatonin 3mg for sale
oral zyban 150 mg – order bupropion 150mg pills buy shuddha guggulu medication
buy xeloda pills for sale – buy ponstel tablets buy danocrine for sale
purchase prometrium online – purchase prometrium pill buy clomiphene generic
fosamax online – order pilex pill buy provera 5mg
order aygestin 5mg online – order aygestin generic buy yasmin tablets
estradiol 1mg ca – ginette 35 uk anastrozole without prescription
buy generic dostinex over the counter – cheap alesse generic alesse brand
how to get prescription drugs without doctor: Canada pharmacy – best ed solution
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі гЃ©гЃ“гЃ§иІ·гЃ€г‚‹ – г‚ўгѓўг‚シル処方 г‚ёг‚№гѓгѓћгѓѓг‚ЇгЃЇи–¬е±ЂгЃ§иІ·гЃ€г‚‹пјџ
жЈи¦Џе“Ѓгѓђг‚¤г‚ўг‚°гѓ©йЊ гЃ®жЈгЃ—い処方 – バイアグラ её‚иІ© гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ г‚·г‚ўгѓЄг‚№йЂљиІ©
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ – гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі жµ·е¤–йЂљиІ© г‚ўг‚ュテインの購入
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
eriacta along – forzest reflect forzest slip
indinavir over the counter – buy generic confido for sale purchase voltaren gel sale
valif online reduce – buy sustiva generic buy sinemet paypal
order provigil 100mg generic – modafinil where to buy buy generic epivir
phenergan buy online – oral ciplox 500 mg lincocin generic
purchase ivermectin – ivermectin 12 mg for sale carbamazepine where to buy
Sao79 Club or Sao Win is a reputable card game portal with more than 500,000 downloads by 2024. Enjoy playing card games, Sic Bo, coin toss, fish shooting, lottery… Sao79 allows cross-platform transactions via Momo Pay, scanned bank codes, transfer, Zalo Pay, scratch cards… along with quick withdrawals to bank accounts, ATM cards. https://sao79.vip/
buy prednisone pills for sale – buy capoten cheap oral captopril 25 mg
buy prednisone 5mg without prescription – buy nateglinide 120mg generic capoten 120mg oral
Access the table for over 100 leagues and find out how your favourite football team has been performing this season. Work out the leading teams by going through the standings and establishing the number of wins, draws and losses so far this campaign. BT Sport was showing United’s Champions League fixtures in the UK, with a live stream option available on BT TV. In the USA, CBS Sports showed select games on TV, and this fixture was also available to stream live on Paramount+. Where to watch Man Utd in the Carabao CupManchester United won the Carabao Cup in 2022-23. the first time have come across this good advice on football, i like it. Odds: 1.64 on Bet9ja The team studied 10 years’ worth of data on nearly half a million football matches and the associated odds offered by 32 bookmakers between January 2005 and June 2015. For every game, they looked for odds that might yield a better return than the average offered by bookies – say, 5 to 1 versus a mean of 2 to 1.
https://www.cartoonmovement.com/cartoonist/34149/
The second match against Ghana ended as a draw and the data showed no significant difference in well-being between soccer spectators and non-spectators (d = 0.06), although a mild trend toward lower spectators’ well-being became apparent. This trend points in the hypothesized direction, suggesting that a draw against an opponent, not expected to pose an actual challenge, as was the case for Ghana, would be associated with declines in well-being among soccer interested participants. Gannett may earn revenue from sports betting operators for audience referrals to betting services. Sports betting operators have no influence over nor are any such revenues in any way dependent on or linked to the newsrooms or news coverage. See applicable operator site for its terms and conditions. If you or someone you know has a gambling problem, help is available. Call the National Council on Problem Gambling 24 7 at 1-800-GAMBLER. Must be 21 or older to gamble.
isotretinoin 10mg oral – order decadron zyvox ca
buy amoxicillin tablets – how to buy valsartan generic combivent 100mcg
oral zithromax 250mg – bystolic 5mg pills buy bystolic 5mg pills
purchase prednisolone online – brand progesterone prometrium 100mg cheap
buy furosemide 100mg for sale – nootropil 800mg for sale betnovate price
gabapentin sale – buy cheap gabapentin itraconazole 100 mg cost
cheap augmentin 1000mg – order augmentin 1000mg sale buy duloxetine pills
oral vibra-tabs – brand ventolin 4mg order glucotrol 5mg online cheap
augmentin 1000mg without prescription – brand ketoconazole duloxetine price
order semaglutide 14 mg online – vardenafil online buy cyproheptadine ca
zanaflex brand – hydroxychloroquine pills buy hydrochlorothiazide 25mg online
order tadalafil 10mg – cialis 20mg pills purchase sildenafil generic
viagra 100mg oral – sildenafil overnight delivery tadalafil 10mg usa
lipitor 20mg tablet – order atorvastatin 20mg generic buy lisinopril for sale
buy cenforce 50mg online cheap – glucophage 1000mg usa order metformin 1000mg
lipitor 40mg pills – buy cheap generic amlodipine buy lisinopril 2.5mg online
order lipitor 10mg generic – amlodipine order order prinivil online cheap
prilosec over the counter – lopressor 50mg us order generic atenolol 100mg
methylprednisolone 8 mg tablet – order pregabalin 150mg for sale order aristocort 4mg pill
order generic clarinex 5mg – clarinex 5mg ca buy generic priligy
order misoprostol for sale – orlistat 120mg uk diltiazem online
Mitolyn scam: Mitolyn scam
Gluco Extend scam: Gluco Extend scam
Quietum Plus scam: Quietum Plus scam
acyclovir 400mg for sale – buy zovirax generic cost crestor
order motilium generic – order domperidone pills cyclobenzaprine us
ارائه تمامی آی دی کارت کشورهای خارجی نظیر امریکا، انگلیس، ترکیه، امارات، آلمان، بحرین، عراق و عربستان بصورت فیزیکی توسط آس مدرک در ایران
انجام احراز هویت بایننس توسط تیم قدرتمند آس مدرک با مدارک معتبر و قیمتی باور نکردنی
خرید اکانت تریدینگ ویو پرمیوم و پلاس و اسنشیال ارزان و اورجینال از آس مدرک با قابلیت تمدید برروی ایمیل شخصی
ارائه خدمات فعال سازی تیک سبز واتساپ ویژه ایرانیان توسط آس مدرک در ایران
خرید سیم کارت فعال انگلیس با قیمت ارزان و تحویل سریع از آس مدرک در ایران
domperidone 10mg price – tetracycline 500mg generic order generic flexeril
where to buy propranolol without a prescription – buy plavix sale buy methotrexate 2.5mg generic
order generic warfarin 5mg – order losartan generic buy losartan 25mg pills
levaquin uk – oral levaquin 250mg order ranitidine online cheap
buy esomeprazole 40mg – order nexium 20mg online cheap sumatriptan 25mg tablet
buy cheap mobic – buy mobic 7.5mg online tamsulosin price
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
zofran generic – cost zocor buy generic simvastatin 20mg
En un espacio delimitado, un jugador por equipo intentará que el globo lanzado por su rival no caiga al suelo. Tan sencillo como eso, aunque el juego tiene reglas. El torneo se lleva a cabo en una pista de juego de 8m x 8m que tendrá distintos obstáculos para complicar las partidas. Los obstáculos y la distribución variarán a medida que avance la competencia. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. El juego «1Win Balloon» está ganando popularidad rápidamente entre los usuarios de Perú, llamando la atención por su jugabilidad única y la oportunidad de ganar dinero utilizando elementos de estrategia y suerte. Muchos usuarios están buscando formas de descargar e instalar este juego, especialmente a través de archivos APK, lo que les permite saltarse las restricciones e instalar el juego directamente en su dispositivo. En esta guía, detallaremos cómo descargar, instalar y usar «1Win Balloon» para que puedas empezar a jugar y divertirte al máximo.
https://abeyroofingandconstruction.skylinelead.com/review-del-juego-mx-balloon-app-por-smartsoft-para-jugadores-mexicanos/
Email * sweet bonanza giris: sweet bonanza slot – sweet bonanza demo sweetbonanza1st.shop sweet bonanza giris: sweet bonanza yorumlar – sweet bonanza demo sweetbonanza1st.shop sweet bonanza: sweet bonanza demo – sweet bonanza demo sweetbonanza1st.shop sweet bonanza 1st: sweet bonanza demo – sweet bonanza yorumlar sweetbonanza1st.shop sweet bonanza giris: sweet bonanza giris – sweet bonanza giris sweetbonanza1st.shop sweet bonanza: sweet bonanza yorumlar – sweet bonanza giris sweetbonanza1st.shop sweet bonanza giris: sweet bonanza – sweet bonanza sweetbonanza1st.shop sweet bonanza oyna: sweet bonanza siteleri – sweet bonanza siteleri sweetbonanza1st.shop sweet bonanza demo: sweet bonanza giris – sweet bonanza yorumlar sweetbonanza1st.shop
provigil 200mg pills modafinil 100mg sale buy generic modafinil online buy modafinil no prescription order modafinil generic modafinil 100mg oral provigil 100mg sale
هل تتساءل ايداع في هذه اللعبة المثيرة؟ هل تريد معرفة توقعات لعبة Crash 1xbet؟ الأمر كله يتعلق بعمل تنبؤات دقيقة؟ أثناء وضع رهاناتك، ضع في اعتبارك عوامل مثل مواقع الهبوط السابقة واحتمالات الدفع. من خلال الممارسة والتفكير الاستراتيجي، يمكنك زيادة فرصك في الحصول على تلك التوقعات الفائزة. انا حملتو وثبتو بس مش راضي يشتغل لما ادوس استارت؟ اغتنم العرض الترويجي وانضم إلى خدمتنا المتميزة الآن! 6.8 من الواضح أن تحميل برنامج المراهنات يوفر لك العديد من المزايا والفوائد التي ستعزز تجربتك في 1xbet تحميل للكمبيوتر وتساعدك على الوصول إلى مستويات عالية واكتساب مهارات إضافية لذا لا تتردد في الاستفادة من هذه الفرصة هكر 1xbet 2023 الآن.
https://shoplook.io/profile/exvekarpai1982
لعبه الطيارات هي لعبة مراهنات متعددة وبسيطة للغاية. يجب عليك التحرك ووضع الرهان قبل بدء جولة اللعب في كازينو 1Win. في لعبة Aviator يتم استخدام أيًا من لوحتي التحكم في الرهان، وبمجرد إقلاع الطائرة تبدأ قيمة مضاعف الأرباح في الزيادة: من تلك اللحظة فصاعدًا يمكنك النقر على زر سحب المال. يمنحك الوضع التجريبي في لعبة Aviator إمكانية اختبار كامل خصائصها. يحصل كل لاعب على رصيد افتراضي (3000 وحدة نقدية) من كازينو 888starz لخوض التجربة. يمكنك وضع الرهانات واتخاذ قرارات صرف الأرباح تمامًا كما هو الحال في وضع استخدام المال الحقيقي. بالنسبة إلى اللاعبين المبتدئين، يعتبر وضع اللعب المجاني بيئة مثالية للتعرف على آليات اللعبة وتطوير استراتيجياتهم الخاصة.
Despite the early setback in his pro wrestling career, Johnson was determined to make a reputation for himself.
Just like bodybuilding star Sam Sulek, when The Rock refuses to talk about PEDs,
followers only begin to ask more questions.
As for Greg Doucette, he is satisfied ‘1,000-to-1’ that Dwayne ‘The Rock’
Johnson achieved his physique with enhancements. Anticipate expert-backed workouts, vitamin advice,
the most recent in energy sports activities, and a complete lot of motivation heading your means.
“The point is you can’t even get there with HRT (hormone replacement therapy). He is so large and he’s so different than he was when he was 30.”
Before throwing round labels, individuals in the media and in online communities need to be educated so as to have
an opinion that carries weight. Former WWE celebrity and well-liked actor
Dwayne “The Rock” Johnson has just lately gone on record about his
steroid use in an interview with Fortune. To many it may not be shocking to listen to that a former professional wrestler has dabbled in steroid use.
He’s a family name, a man whose crossover success
is an inspiration to many young hungry up and comers, whether in wrestling, acting, or other endeavors.
Right Now Dwayne the Rock Johnson is a well-known action and comedy film star, who occasionally visitor stars as a wrestler with World Wrestling Leisure.
After graduating from the College of Miami, Dwayne determined to comply with in his father’s (and grandfather’s) footsteps and become an expert wrestler.
Dwayne was born in California in 1972 and was the son of one other skilled wrestler,
Rocky Johnson. His statements although state that he’s all pure however his extraordinarily ripped physique and
defined muscles tell a different story.
They nonetheless speculate that he makes use of steroids, albeit very discreetly.
And regardless of all of this speculation, the man has stood by
what he said in that interview. Most of his legacy is as a outcome of of his huge physique, which
has wowed fans and the general viewers for years. In fact, it
has led many to take a position about whether or not he takes steroids to
hold up it. His use of the drug goes again to the 1960s — before he entered pro wrestling and before steroids had been unlawful.
Because it was such a new drug, the long-term unwanted facet effects weren’t but recognized, and Graham also considers himself as one of many first to
deliver steroids into pro wrestling. Rey Mysterio is undoubtedly one of
WWE’s most popular superstars of all-time.
Subsequently, whenever you hop on a steroid cycle, your traps
would be the first muscle group to broaden, especially
if you’re taking hormone alternative with a excessive androgen score.
Some individuals are naturally predisposed to build muscle and achieve a
chiseled physique with none external aids. Whereas we can’t definitively assert that Dwayne “The Rock” Johnson has
used steroids, there have been indications that suggest the potential for their utilization. It’s essential to emphasize
that these indicators do not constitute conclusive proof
of steroid use.
This state of affairs is like different celebrities who faced comparable issues10.
It makes us marvel how this could have an effect on his business chances and fan relationships.
The debate on the duty of influencers like Johnson is getting larger.
Recognizing these powerful topics is vital for stars and
their followers to construct a extra open discuss actual health and
honesty within the spotlight9. Every day, he dedicates about an hour and forty five minutes to exercises, doing
weightlifting 5 occasions per week and cardio. His dad, Alan “Rocky” Johnson, and granddad Peter Maivia have
been both wrestling legends.
These indicators are his flushed pores and skin and his massive entice muscle tissue.
As a four-time Mr. Olympia, bodybuilding royalty Jay Cutler represents
an elite class of expertise in the sport and understands
the measures required to attain an impressive physique.
In a recent interview, Jay discusses whether or not
Mike O’Hearn and The Rock are pure, and media’s perception of steroids.
Specialists like Jim Cornette consider that if Johnson admits to using
steroids, it could damage his image and lead others to do the same, setting a risky example11.
The leisure world has seen stars battle with scandals that deeply have an result on their careers and the way folks see them.
This, plus his never-give-up perspective, has made Johnson a logo of health.
He Is a half of wrestling’s story, the place steroids were widespread.
However, Johnson is completely different as a outcome of he focuses on pure methods to remain fit3.
Even in sports like bodybuilding steroid side Effects
the place steroid use is rampant, Ford said talking concerning the matter
is difficult, especially for anybody within the health industry with a following.
At the tip of the day, it doesn’t matter if the legendary Dwayne “The Rock” Johnson uses steroids or not.
Except you might be taking part in competitive sports activities, using
steroids isn’t strictly illegal, offered you could have prescriptions for
it. Flushing is caused when there’s an elevation in physique temperature
brought on because of elevated blood strain. This,
in turn, makes the pores and skin appear relatively darker
or redder than regular, which is claimed to typically arise when an individual
makes use of steroids. That is why many individuals refused to imagine his interview
at the time.
He acquired his hard-working capacity from his grandfather, Peter Maivia.
His profession begins as a footballer in his college days and shortly becomes an expert wrestler.
Though Johnson was born with a gifted genetic household, he was questioned about utilizing steroids due to his
highly ripped and sculpted physique. Johnson was nurtured beneath the professional wrestler ‘Rock Johnson’ and Peter
Maivia, who is a Samoan Wrestler. So many individuals want
the plenty to consider that they were able to attain their physiques with out the help of outside forces.
Many believe that if they admit that they’ve been using efficiency
enhancing medication that it is going to
put an asterisk subsequent to their name. The idea that individuals
would accuse them of being cheats or unnatural is an excessive amount of for some to bear.
Aren’t steroids supposed to make your muscle fibers bigger and stronger?
Nicely, sure, that is what they do, but they where do i buy steroids
not strengthen ligaments and joints. That being said, on a steroid cycle, you could be
using progressive overload somewhat more than you must be and
not deloading correctly because you really feel like Superman, which
leads to a higher danger of harm. For example, your
bench press may feel lighter than it ever has, but
you throw on a weight that you have never accomplished before, and
then increase you tore your rotator cuff. In many cases, the use of
the substance can nonetheless be detected in hint quantities of the
remaining metabolites long after the compound has exceeded its lively life
in the body. So, while a steroid will no longer be offering you with any performance benefits, it
might nonetheless be detected in a drug test many weeks or even months later.
” from a Bayesian perspective, your beginning assumption should be a bonus somewhere within the neighborhood of 10% because of how steroids work. For instance, Lamar Gant deadlifted over 5x his bodyweight weighing 123lbs and 132lbs. I doubt you’ll see a 350lb super heavyweight deadlift 1750lbs any time quickly. This is identified as allometric scaling, and it’s what formulas like Wilks (for powerlifting) and Sinclair (for weightlifting) try to account for.
On the flip facet, its anabolic properties are virtually non-existent, making Halo fairly presumably the world’s finest pure power drug. Don’t count on any weight acquire, even within the type of water retention, although it isn’t uncommon to add a couple pounds of muscle fullness briefly. This PCT was created by Dr. Michael Scally, a hormone alternative expert. This trio of drugs has been efficient in treating 19 men with low testosterone levels (from using anabolic steroids).
It’s also value noting, expectancy also factors in, as I detailed in The Science of Steroids. Simply anticipating a boost in power from steroids can improve acute performance by 4-5%, and improve price of energy acquire by roughly 7-fold. The solely big distinction is that drug-using lifters may have their efficiency around 10% higher than drug-free lifters, if not a bit extra. Occasions such as Raw Unity, USAPL, and IPF function distinctions between tested and untested classes.
In addition, the risk-to-benefit ratio of usage is unfavorable, given the side effects. Anadrol could be very suppressive; it takes several months for endogenous testosterone ranges to appropriate back to a traditional vary. We usually see recovery times shorten by roughly 50% when taking efficient endogenous testosterone-stimulating drugs. This article deals strictly with power sports which would possibly be governed by weight lessons, the place success depends on relative energy (not absolute energy and muscularity).
With Anadrol being a harsh steroid, it will be wiser to stack it with a light injectable steroid similar to Deca Durabolin, as opposed to trenbolone. Selling steroids may end up in as a lot as 5 years in jail and a fine of $250,000. Nevertheless, we now have found Anadrol to be a female-friendly steroid with a low affinity for masculinization unwanted facet effects. Nevertheless, people who genetically reply nicely to Anadrol can expertise elevated well-being because of the large improve in testosterone. 17-alpha-methyl dihydrotestosterone is a potent androgen, which explains why androgenic unwanted facet effects are possible regardless of it having a low androgenic ranking.
In one other research, ladies were given oxymetholone to deal with anemia and bone marrow failure (20). They began on a dose of 1 mg per kg, then elevated in month-to-month increments by 50%, up to a hundred mg per day. Every female was given a dose of no much less than 50 mg of Anadrol per day. However, bodybuilders who use Anadrol in a non-medical setting continue to put themselves in danger. To cut back the risk of harm, bodybuilders can carry lighter weights and perform extra repetitions. This is not going to scale back muscle positive aspects, as we’ve discovered lighter weights to be just as effective for constructing hypertrophy as heavy weights (17).
It’s generally nicely tolerated by women, offering a wonderful introduction to steroids. You have to run a longer cycle with Equipoise due to its long half-life of about 15 days, resulting in a slower onset of effects within the early stages. After you acquire some expertise using a particular steroid, you’ll get a good idea of if you feel the benefits decreasing. You’ll then be able to plan your cycles more exactly to gain most benefit from each steroid. Tons Of of thousands of people have already labored out the easiest way to use them, so there’s little purpose to attempt to reinvent the wheel. Sure, one of many huge benefits of HGH is that ladies can use it with out the virilization that comes with utilizing anabolic steroids. Girls will get comparable advantages from HGH to males, but females will often take a lower dose.
Nuestro sitio es una plataforma de juegos de azar y apuestas deportivas que ofrece, a mayores de 18 años, que cumplan con los requisitos regulatorios, un enorme catálogo de juegos para disfrutar desde donde y cuando quieran. La plataforma brinda los juegos de casino más rentables para jugar en móvil o desde PC. El software de los juegos es certificado, garantizando ganancias justas para todos. Juega gratis a penalty shoot out en modo demo podría avisar si ya ha solicitado el estado de cuenta de PayPal, por supuesto. Si decide no hacerlo, significa que puede perderse el minijuego Duck hunt si está en su teléfono. Los multiplicadores de la apuesta del juego oscilan entre x1,92 y x30,72 en función de cuántos penaltis consecutivos logres marcar. Copyright © 2025 Getwin. Este sitio web es operado por Digital Alliance SRL, una empresa constituida en Costa Rica con número de registro 3-102-680905 con domicilio social en 100 norte 50 este de la Esquina del Sabor, Las Catalinas 9Y Tejar. Digital Alliance SRL está autorizada y regulada en Costa Rica por el gobierno local de EL GUARCO con el número de cuenta 2233.
https://cronosbyte.com/2025/06/03/trucos-y-estrategias-para-ganar-en-lucky-jet-en-1win-colombia/
Moving Out – Puzzle Game Don’t miss out! Download Penalty Kick | Flick Soccer 3D for free now and indulge in endless entertainment of striking football action. Penalty Challenge was created by CodeThisLab. In the exhilarating world of “football strike multiplayer soccer,” the penalty shootout game stands as the ultimate test of nerves and skill. A striker must face the intense pressure of a penalty kick, aiming to outwit the vigilant goalkeeper. The foot strike of the football champion can decide the fate of their team in the Football League, where penalty shootouts are both a science and an art. bug fixes and performance improvements Soccer Game On: Jogos futebol Download more games There are 32 different teams to choose from and have fun in Penalty Challenge! __name_short_html__ soccer strike penalty kick football super league presents an score match football different soccer game environments for penalty goal new season soccer 2019 soccer matches with slow-motion penalty great soccer experience or soccer player experience. In a real football soccer, be your own football manager, customise your 2020 team or team player train to enjoy penalty ultimate victory. As a football match player, get benefit of free penalty strike or free penalty kick with customize freekick or unique soccer kick using unpredictable strike style in football fun league and make super goal.
It gave me a nice feeling before bed especially, simply heat within the sense of
my physique eager to sleep. Identical for the
T3, metabolism definitely elevated and I am very happy with the merchandise of osgear.
Other powerful steroids that are good on burning fat are Stanozolol and Equipoise.
So please use this data as a information and inspiration for creating
your cycles and methods, but don’t take it as the ultimate word that you should stick
with 100 percent. The extra advanced scientific evaluation strategies now
available made this attainable – and it sends an alarm out to anybody who thinks a unfavorable result now means you’re within the clear forever.
These results come about due to how androgens have an result on the
physique and when estrogen function is altered. When doing an IM injection, it’s at all times finest to maintain your syringes separate out of your needles.
Keep an in depth eye in your day by day calorie consumption, and make sure it doesn’t exceed your
minimal wants. Protein and carbs are what you want extra, whereas fat need
to decreased dramatically. Trenbolone can be found in a quantity of forms,
but for slicing function the most environment friendly are Tren-A
or Trenbolone-Acetate. Mixing considered one of
these drugs with Winstrol and Testosterone is among the finest slicing stacks which effectively soften away adipose
tissue. So, what I’ve supplied above is a tenet
that can only be used as an important guide.
I’m often finding new and higher methods to do things,
like changing doses slightly or timing, and so forth. These
specifics are actions we are in a position to only actually experiment with
ourselves, and TAKE NOTE of the professionals and cons of every thing you try.
Not only will their be safety, the results of Equipoise on the metabolism will allow the person to
burn body fat at a much more environment friendly rate.
This does not imply you won’t have to food plan, however
the food regimen can turn out to be more efficient.
Winstrol – also called Stanozolol – is a good steroid for combining weight loss and muscle achieve.
Winstrol increases protein synthesis and nitrogen retention, permitting
you to both build and protect your muscle features after
ending a bulking/enter a slicing cycle. While some steroids are prescribed
medically, anabolic steroids used for muscle building carry
critical well being dangers, including cardiovascular and liver
harm.
While many assume buying steroids online safe (landgoedcampingwesterwolde.nl) are just for bulking,
some truly assist lose fat whereas keeping muscle.
This article will show you the way sure steroids can help in your
fitness journey. No, steroids shouldn’t be used for weight reduction, as
they can lead to severe well being consequences.
While steroids could seem to assist with weight reduction in the short-term, they
will disrupt hormonal balances, resulting in modifications in physique composition and
fats distribution.
You won’t get fats on D-Bal until your diet is totally uncontrolled.
The molecule — a hormone known as adiponectin that’s derived from fat — improved the exercise tolerance and power expenditure of the animals’ muscular tissues.
So, does this imply that having excessive or low levels of testosterone
makes no difference for the body’s capacity to burn fat?
You will shed pounds as long as you feed your body much less energy than it burns, even when you eat essentially the most absolute
junk. Yes, the human body is an “open system”, however nonetheless, you can’t actually escape the laws of thermodynamics.
The FDA and other worldwide regulatory bodies routinely take legal motion towards
websites illegally selling medication, similar to DNP.
Additionally, tren might be notorious for being the steroid that causes essentially the most
quantity of unwanted effects – and it does by far.
It is also identified as the compound that has some of the dramatic impacts on your physique, it’s just that robust, you realize.
Many ladies need to shed pounds, particularly
dreaded stomach fat – but sadly, steroids usually are not the reply.
This is as a end result of way steroids are developed, as they
are based round male intercourse hormones, imitating testosterone.
Weight achieve is extra probably with systemic corticosteroid therapy, by which
steroids are given orally or into the vein and travel throughout
the entire body. However, the glorious news is
that when you stop taking steroid therapy, you’ll find a way
to often shed pounds in 6-12 months. A well-hydrated body burns fats more efficiently and makes you feel
the total vitality. The greatest fats loss steroids stack
is the one run properly and with excessive attention on your safeness.
Some people will use it for months; others will prohibit
themselves to a six or 8-week cycle. This all is dependent upon your goals and if you’re stacking it with steroids,
SARMs, or other fat-burning PEDs. L-tyrosine and iodine
are a typical combination to mitigate anticipated side effects.
In order to play it, you just have to go to the website and register or log in. Then, choose the rocket from the available options. Finally, set the bet amount and click the play button. Playing the JetX game online can be as simple as pressing one button and waiting to press it again. Still, players who are looking for that added value will appreciate the bonus features Smartsoft added to the game. When there is a desire, then it is time to play. The game exists in 2 modes, real and demo version. The game is in automatic mode, you need to credit the bet and start playing. To start playing 1Win Jetx game on real money, as well as take all advantages of the platform, every user has to register, create a 1Win personal account and make a deposit. The process of registration is simple and fast. Use the guide below to start playing jetx game on 1Win right away:
http://www.okaywan.com/home.php?mod=space&uid=664634
In any of the game’s three bonuses (Tiger, Dragon, or Tiger and Dragon Bonus) players want to land as many adjacent gongs in a row as possible, with two or more in a row triggering a credit win. Up Arrows are especially valuable, as they increase credit values exponentially. The following data may be collected and linked to your identity: Live casino games are considered superior to “Video” gambling games, such as Video Poker, as there is less opportunity for the casino to be unscrupulous. Players are watching an uninterrupted stream of the Dealer handling the deck, and there is no unseen algorithm that Players must trust. Many online casino sites and apps allow you to play Dragon Tiger games online with real money. With new technologies, many Dragon Tiger game development companies integrate blockchain and crypto solutions into the game. Now players can easily play these games with various currencies.
70918248
References:
anabolic steroid use
With thanks. Loads of expertise
This is a question which is in to my verve… Numberless thanks Quite where can I notice the contact details in the course of questions?
order generic azithromycin – buy sumycin 500mg metronidazole 400mg tablet
After securing the Internet, the Aviatrix Distributed Cloud Firewall can expand to support East-West control, both between VPC VNets and within a VPC VNet. By attaching the existing egress security gateways to an Aviatrix Transit Gateway, the Distributed Cloud Firewall begins to control traffic between private networks. This has the side-benefit of eliminating costs associated with cloud-native transit solutions. Spinomenal strikes partnership with Lucky7 Casino Features: Whether a business is registered or not, the first three years are most crucial for determining its survival. How the sales are recorded, how inventory is purchased and held, and how stock is delivered or collected from the customer is often the priority of new business owners. However as much as we can support the company with all of that, there are other things that are just as important.
https://lamarlyti1980.cavandoragh.org/view
In Aviamasters™, a maximum multiplier can reach up to x250, depending on how many multipliers the aircraft gathers and the rockets it collides with. As your aircraft advances through the sky and hits the brakes on the surface of the carrier, the game offers frequent payouts thanks to its low volatility Space XY is an interesting new game in the Crash genre from renowned developer Bgaming. Here you can get a big win of up to x10,000 in just two clicks if you’re lucky. In doing so, your decisions affect whether you win or lose. At 1win we offer you the chance to play this game for real money. Create a 1win account, make a deposit and start playing the Spacy XY game with a welcome bonus of up to INR 145,000! You can use this widget-maker to generate a bit of HTML that can be embedded in your website to easily allow customers to purchase this game on Steam.
domperidone 10mg oral – tetracycline usa buy generic cyclobenzaprine
order generic inderal – how to buy inderal order methotrexate 10mg sale
zithromax 500mg canada – order tindamax 500mg pills where can i buy nebivolol
The math model for Sweet Bonanza 1000 is its biggest selling point. The game serves up a maximum win of 25,000x your stake and comes with an above-average RTP of 96.53%. It has also been given a full 5 5 volatility rating from Pragmatic Play, which makes it highly recommendable according to our slot strategy guide. BGaming is ready to introduce a new game in its slot lineup! Meet Bonanza Billion – another fantastic game that will take you into the world of delicious fruits! And if you’re lucky, you’ll thoroughly enjoy a vibrant fruity fiesta filled with magnificent winnings that every sweet tooth will love. As far as looks go, the Sweet Bonanza 1000 slot machine doesn’t really offer much new, with just the addition of fruit making it a little different for many similar games. But that’s not to say it looks bad, as the bright symbols and candy world behind are on a par with others. The soundtrack is quite catchy as well.
https://jszst.com.cn/home.php?mod=space&uid=5776452
Ans. Teen Patti Cash में न्यूनतम ऐड कैश 100 रुपये है। Teen_Patti_Diamond_3_Patti_v3.0.3.xapk Friends today we are going to tell you about Dragon vs Tiger game in Game 3f App let me tell you that Dragon vs Tiger game is the easiest game if you have downloaded Game 3f then try to play Dragon vs Tiger game because this game is the easiest game because I also play it and it gives result in very less time if you want to earn money and also want to save time then please download it and play Dragon vs Tiger King The card game standard UI is also included in the app. Vibrant colors and numerous casino allusions, including cards, chips, trophies, and more, are present in its windows and home screens. Additionally, games employ the standard top-down view, in which only your cards are visible, and the rest are reversed. Together with the sound effects, all these visual components make this game suitable for casual card game players.
order coumadin pill – cou mamide buy hyzaar generic
order mobic sale – swelling purchase meloxicam generic
prednisone 20mg tablet – https://apreplson.com/ purchase deltasone sale
the best ed pill – https://fastedtotake.com/ buy ed pills uk