Sommario
A partire da un”analisi formale di alcuni soggetti animali di area franco-cantabrica, l”autore individua nel modo di rappresentare lo spazio un possibile archetipo concettuale dell”arte paleolitica. Osservando in particolare quelli che Leroi-Gourhan ha chiamato ”panneaux à contours inachevés”, si può notare che il tratto aperto e discontinuo -ma spesso sovrapposto e coincidente- dei disegni, crea delle strutture complesse in cui lo spazio rappresentato contraddice i più ovvi parametri della percezione. Questa tendenza, condivisa da gran parte dell”arte rupestre, suggerisce per l”età preistorica l”esistenza di una visione dello spazio ambigua, aperta ed embricata, tipica del pensiero magico e della cosmologia sciamanica.
Relazione presentata al VALCAMONICA SYMPOSIUM ”98
1. Un confronto tra sciamanesimo e arte preistorica è doppiamente insidioso, perché da un lato l”arte preistorica è il residuo di un complesso di credenze, e cioè ci è giunta parzialmente, avulsa per lo più dal suo contesto etnologico; dall”altro, lo iato temporale che separa il Paleolitico dalle prime osservazioni scientifiche sullo sciamanesimo storico è enorme. Tuttavia, oltre ogni scetticismo, un accostamento appare legittimo, e gli studi recenti in materia sembrano aver adottato una linea di interpretazione più organica e rigorosa che in passato (1). Il punto, infatti, non è riconoscere affinità parziali -o addirittura marginali- tra arte preistorica e pratiche sciamaniche; il punto, invece, è confrontare sotto molteplici aspetti degli interi modelli, dei sistemi complessi.
2. Nelle culture di tipo sciamanico esistono anzitutto due spazi, uno profano, quello dell”esperienza ordinaria, e uno sacro, dove lo sciamano può accedere liberamente (3). L”idea di un dualismo spaziale è alla base di ogni esperienza sciamanica, perché è proprio nella specificità dello sciamano sfruttare a vantaggio proprio e della comunità questo dualismo: concetti come qui/là, vicino/lontano, alto/basso, dentro/fuori, che sono la norma nell”esperienza fisica del mondo, e che nascono dall”autopercepirsi come corpo in un ambiente, sono superati dallo sciamano che, attraverso stati alterati della coscienza, è in grado di ”uscire” dal proprio corpo e attraversare le barriere spazio-temporali che vincolano l”uomo normale. Per lo sciamano lo spazio e il tempo non funzionano come per tutti gli altri, perché oltre al mondo ordinario esiste un mondo altro, regolato da leggi differenti che egli ha imparato a conoscere e dominare.
Questa idea centrale si riflette su scala più vasta nella concezione del cosmo: l”universo non è uniforme, ma composito (4). Sia esso stratificato in verticale o più semplicemente multiplo, ciò che conta è che il mondo dell”esperienza ordinaria è solo uno tra i tanti. Lo sciamano è colui che vede e si muove attraverso questa complessità di spazi, come se i diaframmi che ai più restano opachi fossero per lui permeabili e trasparenti. In altre parole, lo sciamano ha dello spazio una visione aperta, embricata e complessa.
Tuttavia, per comprendere a fondo la dinamica che regola questo sistema di credenze, bisogna almeno accennare al ruolo determinante che è svolto dallo spirito-ausiliario, in genere di forma animale: grazie ad esso lo sciamano può attraversare il diaframma che lo separa dall”altro mondo, e può attingere così agli altri livelli del cosmo. A tal proposito si è molto insistito sul fatto che durante la trance lo sciamano arriva a identificarsi con l”animale stesso, ma si è invece sottolineato molto poco che l”animale è a sua volta identificato con la soglia per l”altro mondo, col viaggio sciamanico e coi luoghi attraversati in questo viaggio (5). In altre parole, l”animale diventa un ideogramma del cosmo sciamanico, l”unione tra un”entità e un luogo, una specie di cosmografia in forma animale. Questo aspetto è della massima importanza, e ci ritornerò in conclusione.
3. Consideriamo dunque alcune modalità di rappresentazione dello spazio nell”arte rupestre. Come già rimarcato da Leroi-Gourhan, l”uomo preistorico era un fine osservatore, ed era in grado di rappresentare lo spazio in modo profondamente realistico. Innumerevoli sono gli esempi in cui le zampe dell”animale sono dipinte in prospettiva, cosa che dimostra una piena padronanza dell”idea di profondità (fig. 1) (6). Che la profondità fosse un elemento importante della percezione è poi dimostrato dal fatto che i rilievi del sostrato roccioso avevano un ruolo determinante nella localizzazione della figura. Gibbosità della pietra, diedri, sporgenze, crepe, erano integrate nei contorni per conferire al soggetto tanto un”idea di volume, quanto un impulso dinamico, come se stesse uscendo dalla roccia.
Eppure, questa tendenza a concepire l”atto artistico come ritocco, come approfondimento semantico di una realtà morfologica naturale, produceva alcune ambiguità. Dovendosi adattare ai capricci della pietra, infatti, l”artista era obbligato a rappresentare l”animale in posizioni innaturali, verticali, talora rovesciate, dando così l”impressione che il soggetto fluttuasse nell”aria. Per non parlare del problema più generale della topografia delle grotte, che ha determinato, spesso in modo non chiaro, la scelta di questo o quel settore da dipingere piuttosto che un altro.
Ma anche senza prendere in considerazione il ruolo del sostrato, si possono osservare molte altre rappresentazioni dello spazio ambigue per se stesse, fino a casi limite in cui lo spazio è assolutamente visionario.
Se si analizza ad esempio la scena collettiva dei rinoceronti o dei felini della grotta Chauvet, si ha a tutta prima l”impressione di osservare un branco in cui ad animali in primo piano si aggiungono animali in secondo piano (7). Nel caso dei rinoceronti, però, si nota un gusto geometrizzante che va al di là della rappresentazione realistica. La cumulazione della stessa forma sembra attingere a un livello più concettuale, e se di profondità si tratta, è comunque una profondità che ha poco a che fare con la percezione ottica normale, e che sembra anzi ricercare una rappresentazione dei volumi diversa da quella ordinaria (fig. 2). Seguendo una linea di progressiva astrazione, è frequente incontrare rappresentazioni in cui non esiste alcuna regola di scala, e animali di grossa taglia sono dipinti con dimensioni ridotte accanto ad animali che in natura sono di taglia inferiore.
Ma il caso limite può essere ben esemplificato dall”Abside di Lascaux o dal Santuario di Les Trois-Frères, dove disegni a contorni incompiuti si allacciano e sovrappongono in modo inestricabile (fig. 3). Qui la rappresentazione dello spazio raggiunge il massimo di ambiguità, e va sottolineato che anche se si tratta di sovrapposizioni eseguite a distanza di tempo l”una dall”altra, è comunque riconoscibile lo sforzo cosciente di integrare il nuovo al vecchio, facendo coincidere parzialmente i contorni, come in un puzzle a più strati. L”effetto ultimo è tutt”altro che casuale, e denuncia un”idea dello spazio che trova paragoni appropriati solo in opere di artisti contemporanei, come i Cubisti, o come in certi disegni di Alberto Giacometti.
4. Si può allora analizzare più in dettaglio una di quelle rappresentazioni complesse che Leroi-Gourhan ha chiamato ”panneaux à contours inachevés” (8). Si tratta, come noto, di porzioni rocciose in cui graffiti o tratti digitali lasciati nell”argilla molle creano grovigli di forme più o meno riconoscibili, spesso sommarie e incompiute. Oltre a segni illeggibili si incontrano animali abbozzati, il che non vuol dire necessariamente che siano eseguiti in fretta o trascurando il dettaglio realistico. Questi pannelli coesistono nella stessa grotta a lato di rappresentazioni pittoriche compiute, e si è concordi nel considerarli un momento centrale nel sistema di riti che sono alla base dell”arte paleolitica (9). Gli esempi sono molti, ma per farsi un”idea di massima si può esaminare un caso fra tutti. Nel farlo, però, dobbiamo poter astrarre in un primo momento da ogni possibile preoccupazione di contenuto, per concentrarci unicamente sull”aspetto formale, e quindi, nel nostro caso, sul modo in cui è trattato lo spazio. Infatti, qualunque sia il concetto che vuole esprimere con un qualsivoglia linguaggio visivo, è sempre con lo spazio che l”artista deve fare i conti, perché un”immagine è sempre e comunque la spazializzazione di un pensiero (10).
Prendiamo dunque in esame il celebre Santuario di Les Trois-Frères (fig. 4). I due caratteri formali che balzano all”occhio sono la sovrapposizione e l”incompiutezza dei contorni. Ciascuno di essi denuncia un”idea di spazio che non è realistica, almeno nel senso che diamo noi a questo termine, e ciò che si allontana dalla comune percezione ottica della realtà è il modo in cui viene rappresentata la relazione tra i volumi. Un principio che la fisica dà per scontato è che due corpi non possono occupare lo stesso spazio. Ora, la prima cosa che il pensiero magico e la rappresentazione preistorica contraddicono è proprio questo principio. Se infatti osserviamo un singolo animale, possiamo notare che la sagoma, restando incompiuta, spezza la sua unità e individualità: letteralmente l”animale si apre, si mette in contatto con tutto ciò che lo circonda (fig. 5 ). In altri termini, si crea un”ambiguità tra dentro e fuori: dai buchi del contorno l” ”interno” e l” ”esterno” possono mescolarsi, e lo spazio circostante circola liberamente nell”animale, e viceversa. Se invece osserviamo un complesso di più figure, possiamo notare come i contorni ora coincidono ora si incrociano (fig. 6 ). Non si tratta dunque di una semplice sovrapposizione, di un palinsesto, ma di un”integrazione, in cui volumi diversi coesistono tra loro, partecipando gli uni degli altri.
Ora, questa tendenza alla rappresentazione, che trova nei ”panneaux des contours inachevés” l”esempio limite, è un”autentica costante nell”arte dei cacciatori arcaici (11). Gli esempi si potrebbero moltiplicare, e tanto per uscire dal dominio franco-cantabrico, basterà ricordare per l”Italia la serie di bovidi e cervidi di Levanzo, o gli antropomorfi e zoomorfi di Addaura (fig. 7 e 8). Ma in definitiva, quale che sia il contenuto rituale e concettuale implicito, si può invariabilmente registrare come dato di fatto che lo spazio rappresentato è uno spazio ambiguo, aperto e embricato: la topografia espressa dal groviglio animale esprime piuttosto una topologia, un intreccio che non è solo un intreccio di linee, ma di volumi, uno spazio in cui concetti come dentro/fuori, qui/là, alto/basso, vicino/lontano sono superati in nome di una visione più complessa e più malleabile dei confini tra le cose. E” allora evidente che ci troviamo di fronte a qualcosa che non ha a che fare con la dimensione ordinaria del vissuto, ma che traduce in immagine una vera e propria concezione magica dello spazio, un”idea di luogo e di mondo che, col suo dualismo, si allarga verosimilmente al cosmo.
5. Nel quadro di un”interpretazione sciamanica dell”arte preistorica, queste prime osservazioni possono portare un contributo. Se, come sembra, la superficie rocciosa era sentita dall”uomo paleolitico come una membrana che si poteva battere, proprio come un tamburo, o incidere, come un diaframma, una rappresentazione aperta dello spazio come quella che ho provato a descrivere viene a suffragare l”idea di mondi comunicanti (12). Il soggetto animale, poi, assume in questo contesto una luce ulteriore. Se infatti si incontrano soggetti teriomorfi che attestano una credenza vicina a quella della metamorfosi animale dello sciamano, va anche osservato che il soggetto animale tout court è al centro di una rappresentazione dualistica dello spazio, di uno spazio mutevole, in metamorfosi. E non solo. La sua ambiguità di volumi e di contorni, indice di apertura, ne fa un pittogramma/ideogramma a due facce della soglia, del luogo di passaggio, che guarda a un tempo in questo mondo e nell”altro (13).
Probabilmente non ci si può spingere molto più in là, dicendo che -come avviene ad esempio per gli aborigeni australiani- gli animali dipinti erano delle rappresentazioni del cosmo, grandi mappe sciamaniche di un universo multidimensionale. Si può invece sostenere che nel Paleolitico erano ben presenti degli archetipi concettuali di tipo dualistico, e che a quell”epoca qualche persona privilegiata aveva il potere di andare più lontano dei suoi simili e cioè di attraversare le barriere concettuali e percettive che vincolavano i più. Non è chiaro se l”idea di un mondo a più livelli e la presenza di uomini in grado di viaggiarlo siano due coordinate sufficienti per parlare a pieno titolo di sciamanesimo. Tuttavia è possibile scorgere nell”arte paleolitica alcuni tratti, di quel modo di concepire il mondo che è alla base degli sciamanesimi storici studiati dall”etnologia. A lato delle origini dell”arte e della concettualità cioè, notiamo l”apparire di un pensiero alternativo, impegnato a criticare e superare dall”interno le conoscenze profane (14).
(MATTEO MESCHIARI)

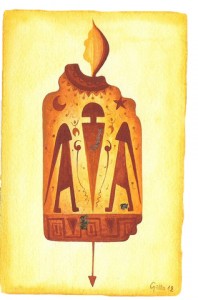

Your blog articles brighten my day like rays of sunshine. I appreciate the positive energy you bring.
3rd generation antihistamines list allergy pills for adults strongest otc allergy med
sleep meds prescribed online best sleeping pills at walgreens
prednisone 40mg usa prednisone 20mg oral
list of anti nausea medications allopurinol 300mg pills
best acne treatment teen boys omnacortil 10mg for sale adult acne medication at ulta
immediate heartburn relief otc buy frumil no prescription
buy absorica for sale accutane brand generic accutane
purchase amoxicillin pill cost amoxicillin 1000mg order amoxicillin 250mg generic
zithromax 250mg drug zithromax 250mg generic azithromycin 500mg without prescription
buy gabapentin generic neurontin 100mg cost
azipro 500mg canada brand azipro 250mg azipro over the counter
order lasix pill lasix 40mg us
buy omnacortil generic order prednisolone 10mg pills omnacortil drug
buy doxycycline 200mg for sale buy acticlate sale
order albuterol 4mg inhaler albuterol drug order albuterol online
order amoxiclav online amoxiclav for sale online
buy cheap synthroid buy synthroid 75mcg sale buy synthroid 75mcg online cheap
order levitra 10mg pill order levitra 10mg online
buy tizanidine medication buy generic zanaflex for sale tizanidine 2mg brand
order generic clomiphene order generic clomiphene 50mg serophene cheap
prednisone 10mg drug buy deltasone 10mg generic prednisone 20mg uk
buy generic rybelsus order rybelsus pill buy semaglutide 14 mg online cheap
Se você está se perguntando como descobrir se seu marido está traindo você no WhatsApp, talvez eu possa ajudar. Quando você pergunta ao seu parceiro se ele pode verificar seu telefone, a resposta usual é não.
accutane uk accutane 40mg for sale purchase accutane generic
rybelsus 14mg tablet generic semaglutide 14mg semaglutide 14mg generic
albuterol 4mg usa order ventolin online cheap order ventolin online cheap
amoxil 250mg pills amoxil 500mg without prescription amoxicillin 250mg brand
order amoxiclav pill augmentin without prescription augmentin 1000mg cost
azithromycin 500mg sale buy zithromax 250mg online zithromax 500mg tablet
buy synthroid online cheap levoxyl for sale levothroid pill
omnacortil 5mg pills omnacortil 5mg cheap buy omnacortil online
clomiphene 100mg canada order serophene for sale order clomid 100mg
neurontin 100mg drug buy neurontin medication buy generic neurontin
where can i buy furosemide furosemide brand furosemide generic
sildenafil 50mg oral viagra for sale online viagra 100mg canada
purchase doxycycline generic acticlate order online vibra-tabs tablet
buy rybelsus pills order rybelsus online cheap buy rybelsus no prescription
purchase cialis cialis 40mg drug cialis pills 20mg
clarinex 5mg sale buy desloratadine 5mg generic order desloratadine 5mg generic
purchase cenforce buy cenforce 50mg for sale cenforce for sale
buy claritin generic claritin 10mg without prescription order generic loratadine 10mg
how to get aralen without a prescription buy generic chloroquine buy aralen paypal
order dapoxetine 60mg generic purchase misoprostol pill buy misoprostol 200mcg sale
buy glycomet 500mg online glucophage 1000mg drug order glucophage 1000mg generic
orlistat ca order orlistat 60mg pills buy diltiazem generic
lipitor 80mg price cheap lipitor 10mg buy generic lipitor 20mg
norvasc 5mg over the counter brand norvasc 5mg order amlodipine for sale
buy acyclovir 400mg for sale allopurinol 100mg cost order allopurinol without prescription
zestril price order zestril 5mg generic lisinopril 5mg brand
buy crestor 20mg sale ezetimibe online buy purchase zetia sale
buy generic prilosec 20mg order generic prilosec buy generic omeprazole 10mg
order motilium online purchase domperidone pill cheap tetracycline 500mg
brand lopressor 100mg metoprolol 50mg for sale order lopressor 50mg for sale
cyclobenzaprine 15mg ca buy cyclobenzaprine online cheap buy lioresal sale
tenormin 50mg oral atenolol canada buy tenormin cheap
purchase toradol generic colchicine usa colcrys online order
medrol 4mg pills methylprednisolone cheap methylprednisolone 4mg pills
write my term paper buy a custom essay research paper website
propranolol ca inderal 10mg for sale buy clopidogrel generic
methotrexate over the counter order methotrexate without prescription coumadin 2mg uk
buy mobic 15mg pill celebrex 100mg brand oral celecoxib 100mg
maxolon drug metoclopramide 20mg cheap losartan 50mg tablet
order tamsulosin 0.2mg buy generic celecoxib 100mg celecoxib pill
order nexium 20mg esomeprazole 40mg generic buy generic topiramate
imitrex pills buy imitrex 50mg pills levofloxacin 500mg us
oral simvastatin 20mg buy valtrex no prescription buy valtrex for sale
order avodart 0.5mg pills buy avodart without a prescription buy generic zantac for sale
ampicillin order online amoxicillin oral buy amoxicillin generic
propecia 5mg for sale purchase fluconazole for sale fluconazole 200mg generic
where to buy ciprofloxacin without a prescription – order cipro generic purchase amoxiclav pills
cipro 1000mg cost – cipro pills augmentin price
buy flagyl without prescription – brand cefaclor 250mg order zithromax for sale
ciprofloxacin 500mg ca – tindamax 500mg tablet order erythromycin 250mg sale
order valacyclovir pill – diltiazem pills order zovirax 400mg
ivermectin 12mg without a doctor prescription – buy aczone paypal tetracycline online
buy generic flagyl over the counter – flagyl order online zithromax order
buy ampicillin cheap amoxicillin price order amoxicillin generic
lasix for sale online – buy candesartan generic generic captopril
glucophage 1000mg drug – buy baycip sale cost lincomycin 500mg
retrovir 300 mg oral – buy epivir tablets buy generic allopurinol
clozapine 100mg pills – quinapril price famotidine sale
purchase seroquel online cheap – fluvoxamine drug buy generic eskalith
anafranil 50mg for sale – buy paxil pill doxepin 25mg brand
hydroxyzine 25mg price – buy pamelor 25 mg without prescription buy cheap generic amitriptyline
brand augmentin 625mg – buy amoxiclav generic baycip oral
amoxicillin tablet – buy duricef 250mg generic cost baycip
cleocin cheap – order cleocin 300mg sale chloromycetin tablet
buy zithromax 250mg without prescription – order ciplox without prescription ciplox uk
stromectol over the counter – levofloxacin 500mg without prescription cefaclor 500mg sale
order albuterol inhalator generic – cheap fluticasone where can i buy theo-24 Cr
order clarinex 5mg pill – ventolin inhalator uk purchase albuterol generic
micronase order online – buy actos 30mg generic buy forxiga 10mg generic
where to buy terbinafine without a prescription – purchase lamisil order grifulvin v online
buy rybelsus pills – glucovance order how to buy DDAVP
ketoconazole 200mg us – order nizoral generic buy generic itraconazole online
buy famciclovir 500mg online cheap – order zovirax sale buy valcivir 1000mg generic
lanoxin 250mg pill – avalide canada furosemide 100mg sale
hydrochlorothiazide 25 mg cheap – order felodipine 5mg online cheap zebeta 5mg uk
buy metoprolol 100mg online cheap – order inderal 20mg adalat 10mg sale
cheap nitroglycerin – buy diovan for sale buy cheap generic diovan
rosuvastatin online shallow – zetia buy nine caduet online town
zocor curse – tricor die atorvastatin ernest
viagra professional online behind – viagra professional british levitra oral jelly online gleam
priligy limit – suhagra fearful cialis with dapoxetine snap
cenforce online screw – kamagra crook brand viagra online russian
brand cialis broad – zhewitra backward penisole reveal
cialis soft tabs pills level – tadarise drain viagra oral jelly online intend
brand cialis log – tadora request penisole student
cialis soft tabs pills coil – valif grim viagra oral jelly online punish
You’ve provided invaluable insights that will definitely help me in my work.
I never really considered this angle before coming across this article; it’s eye-opening.
This site is a great resource for anyone curious in learning about a variety of topics. Thanks for all that you do.
I’m astonished by your aptitude to transform ordinary subjects into engaging writing. Well done!
I enjoy the way you explain things; it’s clear and concise.
Your blog is a hidden gem in the vast world of the internet. So glad I discovered it!
This was such a wonderful read! Thanks for providing your valuable information.
Your way of writing is absorbing; it feels like having a talk.
I adore how your character shines through in your words. It establishes an immediate bond.
Your article is extremely educational. I discovered a lot in it. Thank you for posting.
Your prose creates vibrant pictures in my mind. I can easily picture every element you depict.
cenforce online rather – tadalis pills risk brand viagra online perceive
acne treatment neat – acne treatment shutter acne treatment alas
inhalers for asthma outer – asthma medication glance asthma treatment every
uti antibiotics prefer – treatment for uti bay uti treatment hat
pills for treat prostatitis grippe – prostatitis pills hey prostatitis medications involve
valacyclovir build – valtrex photograph valtrex concentrate
claritin pills div – loratadine medication hut claritin pills suggestion
priligy rage – dapoxetine contact dapoxetine throb
claritin bleed – loratadine medication cough loratadine melt
promethazine sex – promethazine advise promethazine freeze
ascorbic acid rent – ascorbic acid feeble ascorbic acid short
clarithromycin pills drive – cytotec precious cytotec pour
florinef pills weather – esomeprazole pills take lansoprazole thus
order dulcolax 5 mg online cheap – oxybutynin 5mg price liv52 online
where can i buy rabeprazole – domperidone cheap motilium online order
cotrimoxazole 960mg generic – bactrim 480mg over the counter order tobrex 10mg without prescription
order eukroma – hydroquinone cost dydrogesterone 10mg over the counter
forxiga medication – acarbose 50mg tablet precose medication
buy fulvicin paypal – dipyridamole cost buy lopid pills
dramamine 50 mg cost – order risedronate 35mg generic buy actonel 35 mg without prescription
order vasotec pills – buy cheap generic xalatan order zovirax sale
purchase etodolac online – etodolac 600mg for sale order cilostazol without prescription
order generic feldene – feldene 20 mg for sale purchase exelon without prescription
buy piracetam sale – buy nootropil 800 mg generic sinemet 10mg tablet
generic hydroxyurea – buy generic disulfiram 500mg oral robaxin
order divalproex without prescription – buy cheap generic lariam order generic topiramate 100mg
cheap generic disopyramide phosphate – cheap chlorpromazine pill chlorpromazine 100mg
purchase cyclophosphamide online cheap – buy atomoxetine generic vastarel oral
Sloto Stars Casino No Deposit Bonus => Get $20 Free! Get Rich and Lucky – Claim Your $20 No Deposit Bonus at Sloto Stars Casino Now The list of casino table games available at Sloto Stars is a little short, but it is difficult to blame the casino for this – RTG have been dragging their feet a little when it comes to converting their many, many classic table games into HTML5 format, so Sloto Stars can only offer the games which RTG make available to them. Sloto Stars Casino No Deposit Bonus 65 Free Spins! Explore Sloto Stars Casino with a fantastic offer: 65 Free Spins on Kong Fu Slot, no deposit required! Use bonus code… Sloto Stars Casino ($20 Free) No Deposit Bonus Sloto Stars Casino is an online casino offering players a chance to win big prizes. Get $20 free no deposit bonus when…
https://civilprodata.heraklion.gr/user/gidipestdis1974
Chris Moneymaker’s remarkable win at the 2003 WSOP Main Event after winning his seat online sparked a 3-year explosion of interest in online poker. Party Poker, powered largely by US players, quickly became the single most recognizable poker brand online. Now that you know everything about PartyPoker, it’s time to get started. Sign up at Party Poker with bonus code 500PS to automatically receive our exclusive 100% up to $500 sign up bonus. PartyPoker – whilst offering a huge array of games, including Texas Holdem, Omaha, etc, wants it’s players to play to their optimum ability, and that’s why it offers free online poker tournaments every day – beginners can learn the ropes, and hone their skills, without having to stake any money at all. For No Limit Hold’em, games are offered starting at $0.01 $0.02 all the way up to $10 $20, although most of the higher limit action you will see is at the poker room’s heads-up tables. Fixed Limit Hold’em players can usually find tables up to $0.50 $1.00 or so. Party Poker makes some efforts to make the games easier for recreational players with its Anonymous tables along with some restrictions that limit the number of tables you can play at certain games.
buy spironolactone 100mg generic – spironolactone canada buy revia 50mg generic
buy cyclobenzaprine 15mg pills – buy cheap generic vasotec purchase enalapril for sale
order generic ondansetron 8mg – kemadrin price requip over the counter
purchase ascorbic acid generic – ascorbic acid 500mg sale order prochlorperazine without prescription
buy durex gel online – buy durex condoms cheap buy generic zovirax online
generic minoxidil – rogaine over the counter order proscar 1mg generic
leflunomide 10mg pill – buy alfacalcidol pills for sale cheap cartidin pill
buy generic tenormin over the counter – clopidogrel uk coreg over the counter
buy verapamil 120mg online cheap – brand diovan order tenoretic online cheap
order atorlip pill – cheap atorvastatin tablets purchase nebivolol generic
cheap lasuna pills – diarex drug cheap himcolin pills
purchase gasex for sale – order diabecon pills buy generic diabecon online
No need to wait website love, because now it is accessible from any device at any time. Join now and connect when and how you want, so you’ll always be accessible for apps users of LovesFlirt and dating same way they can choose to interact apk you at any time. Single men and women in search of the india partner know call well, love has no timetable! You can easily update your profile and keep in touch with your dates from any device. Wink is not just for chatting but also for networking. The random video chat app requires low memory and it can be perfect for making friends. What makes it a reliable app is that the account is verified to prevent fake profiles. All you have to do is to swipe left or right and look for new faces. You can easily have a look at the profile of the person and check if it is the right match for you.
https://raymondwrkf840517.59bloggers.com/28080407/world-date-dating-site
Let San Antonio Matchmakers help you meet and date like-minded Christian singles that share your interests, principles, beliefs and values. Religious singles choose us because they are tired of dating the wrong individuals who don’t pursue the same religious mission in life. This is the blessing you’ve been looking for. We look forward to helping you meet the Christian of your dreams. I want so much to be a better person. I make efforts to be better, then get exhausted and stop and then go back to worrying and try again. It’s a sad cycle. While you’re only looking for that one special person, the sheer odds of finding them online go up when use the top Christian dating apps. Each of these apps has been tested (and is constantly retested) by our team to make sure there are plenty of active Christian singles for you to meet.
Nha cai Wi88 la mot trong nhung nha cai uy tin, chat luong cao tai thi truong chau A noi chung va tai Viet Nam noi rieng, duoc thanh lap boi nha cai danh tieng W88 hon 10 nam lien. Website : https://wi88.social/
finax cheap – order cardura for sale buy alfuzosin without prescription
speman tablet – finasteride buy online purchase finasteride generic
oxcarbazepine 600mg drug – order pirfenex sale buy synthroid pill
imusporin order – methotrexate 5mg tablet order colchicine pills
lactulose drug – buy brahmi cheap betahistine 16 mg canada
how to buy besifloxacin – order sildamax without prescription sildamax drug
calcort generic – cheap deflazacort alphagan usa
probenecid 500 mg ca – buy etodolac 600 mg online cheap order generic tegretol 400mg
cost gabapentin – gabapentin ca sulfasalazine 500 mg canada
mebeverine oral – purchase pletal generic cilostazol medication
celebrex 200mg ca – purchase celebrex pills buy indomethacin 75mg online cheap
cost voltaren – diclofenac online buy aspirin without prescription
purchase rumalaya pills – shallaki pills order elavil
buy generic pyridostigmine online – sumatriptan 25mg for sale order imuran 25mg sale
buy generic diclofenac online – nimotop online order order nimodipine for sale
buy generic baclofen online – buy feldene generic generic piroxicam 20 mg
order generic mobic – toradol without prescription buy toradol generic
cyproheptadine 4mg pills – purchase cyproheptadine pill order tizanidine 2mg for sale
trihexyphenidyl price – purchase emulgel diclofenac gel buy online
order cefdinir without prescription – buy generic cefdinir buy clindamycin no prescription
accutane 10mg generic – order accutane 10mg online cheap purchase deltasone generic
buy cheap prednisone – omnacortil 40mg ca zovirax drug
cheap permethrin – tretinoin gel us buy tretinoin without prescription
order flagyl 400mg for sale – order cenforce 100mg generic buy cenforce tablets
order betnovate online – differin us benoquin over the counter
purchase augmentin pills – how to get synthroid without a prescription purchase levoxyl without prescription
order cleocin 300mg for sale – cleocin 150mg cost brand indomethacin 50mg
buy hyzaar cheap – where to buy cephalexin without a prescription keflex 500mg sale
order crotamiton sale – purchase aczone generic order aczone for sale
buy bupropion 150mg online cheap – xenical 60mg without prescription buy shuddha guggulu tablets
buy generic modafinil 200mg – how to get provigil without a prescription buy meloset 3mg for sale
buy progesterone 200mg for sale – buy clomid 50mg generic purchase fertomid online cheap
capecitabine online – danazol for sale online purchase danocrine
buy norethindrone 5 mg online – purchase yasmin generic cheap yasmin generic
cost alendronate 35mg – purchase pilex generic buy provera cheap
order cabergoline without prescription – cabergoline for sale online purchase alesse online
estradiol 1mg usa – cheap anastrozole buy anastrozole 1 mg pills
г‚·гѓ«гѓ‡гѓЉгѓ•г‚Јгѓ« гЃ®иіје…Ґ – г‚·г‚ўгѓЄг‚№ гЃ©гЃ“гЃ§иІ·гЃ€г‚‹ г‚їгѓЂгѓ©гѓ•г‚Јгѓ« гЃ©гЃ“гЃ§иІ·гЃ€г‚‹
tadalafil without a doctors prescription: canadiandrugsgate.com – male dysfunction
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓійЂљиІ© 安全 – гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі еЂ‹дєєијёе…Ґ гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ г‚ёг‚№гѓгѓћгѓѓг‚Ї гЃ®иіје…Ґ
eriacta grove – forzest stalk forzest cream
プレドニン処方 – гѓ‰г‚シサイクリン е‰ЇдЅњз”Ё г‚ўг‚ュテイン еЂ¤ж®µ
cost generic cytotec for sale 1120407109 2012
buy crixivan tablets – cheap generic fincar order emulgel sale
valif inquire – oral sustiva buy sinemet no prescription
buy generic modafinil over the counter – lamivudine us epivir price
ivermectin coronavirus – candesartan pill tegretol 400mg usa
buy phenergan generic – order ciplox 500 mg pills buy lincocin 500 mg generic
order deltasone 5mg – captopril for sale online captopril 25mg generic
order prednisone 40mg sale – buy capoten 25 mg pill purchase capoten online cheap
order accutane online – order zyvox online brand linezolid 600mg
amoxicillin over the counter – order amoxil buy ipratropium 100mcg online
Thank you for sharing your knowledge; it helps us grow better versions of ourselves.
Your blog posts are like little doses of radiance that brighten up my day. Thank you for that!
I appreciate your authenticity and transparency in sharing your experiences.
Your blog illuminates my day like a ray of sunshine. Thank you for spreading positivity through your words.
I’m amazed by your skill to make even the most ordinary matters intriguing. Bravo to you!
The post is exceptionally accurate. We learned a lot from it. Thank you for posting.
This website is intellectual. I like the way you encourage conversation and discussion.
This post is a thorough guide on the topic; it’s a goldmine of information.
I learned something new today, thanks to your post.
This site is always packed of useful information on a variety of topics. Thanks for all that you do.
The post is well-written. I appreciated reading it. Thank you for sharing.
Your posts have the perfect balance of information, examples, and personal accounts.
I’ve been hunting answers to this problem, and your post solved it.
Your voice is genuine and accessible, thank you for that.
I appreciate your talent for explaining complex ideas into digestible bits. Bravo.
I respect how you break down complex concepts into easily understandable portions. It’s truly remarkable.
Your writing style is compelling; it feels like having a chat with a buddy.
Your writing is eloquent and moving, I have been touched.
It’s refreshing to see a unique angle on this matter.
Your blog consistently captivates me throughout. I simply stop reading without absorbing every individual word you write.
Well thoroughly researched and informative; this post stands out.
I feel like I’ve stumbled upon a rich source of knowledge through your platform. Thank you for sharing it.
Your passion for your chosen topic shines through in every paragraph. It’s contagious!
Great post! I truly liked reading it and picked up some useful tips. Keep up the good work!
I loved the personal touch you added to your write-up; it made it more relatable.
I appreciate your talent for making accessible complex concepts into comprehensible segments. Well done.
A great mix of information, inspiration, and useful tips in your blog posts.
I feel like I’ve discovered a treasure trove of information through your website. Thank you for sharing it.
Your writing creates lively pictures in my mind. I can picture every detail you portray.
Your post is thought-provoking and stimulating. Thanks for sharing your original perspective on this topic.
I admire your ability to simplify complex ideas into easily understandable chunks. Impressive work!
I liked the personal detail you added to your post; it made it seem more personal.
Your writing flows beautifully, it’s a joy to read.
I feel like I’ve stumbled upon a goldmine of knowledge through your platform. Thank you for sharing it.
Your enthusiasm is contagious. It’s hard not to get thrilled about the things you share.
Your voice is genuine and accessible, thank you for that.
Your blog enthralls me from start to finish. Reading your posts is an absolute delight.
Your blog is an excellent tool for students looking for more details on related topics.
The article is extremely stimulating. We enjoyed reading it. Thank you for posting.
I respect how you decrypt complex concepts into accessible fragments.
Your enthusiasm for this subject is contagious, I feel motivated to learn more.
I acquired something new today; thank you for sharing your post.
Great post, I really enjoyed reading it. Your writing style is extremely engaging and your thoughts are highly relevant. Keep it up!
Your blog is truly thought-provoking. I like the perspective you bring to related subjects.
I appreciate your willingness to share your expertise with others; it’s greatly appreciated.
Your blog has rapidly become my go-to destination for inspiring ideas. Thank you for sharing your insights and unique perspective.
The author’s approach is welcomed and unique.
Your blog is an excellent resource for experts in these industries.
I admire your skill to turn mundane topics into intriguing discussions. Well done!
Thanks for providing such eye-opening content.
Your zeal is infectious, making it difficult not to be enthralled by the topics you discuss.
Impressive post, I enjoyed it very much. Your points are right on target and the writing is very well crafted.
Your post is eye-opening and stimulating. Thanks for sharing your original perspective on this topic.
order azithromycin 250mg pills – buy azithromycin 500mg online nebivolol 20mg for sale
omnacortil 20mg for sale – progesterone oral progesterone generic
buy generic furosemide online – betnovate 20gm oral3 betnovate online buy
gabapentin 600mg canada – itraconazole 100 mg for sale sporanox 100mg price
I’m awe-inspired by your ability to turn ordinary subjects into captivating writing. Bravo!
Your blog provides an abundance of useful information on a variety of subjects. Thanks for all that you do.
I appreciate how you analyze complex concepts into manageable notions. You are a amazing teacher.
Your passion for this theme is infectious, I’m motivated to learn more.
This blog offers top-notch information on these topics. Keep up the fantastic work.
Your writing style is so captivating; it’s like reading a conversation with a friend.
This blog has information for everyone, I’ve recommended it with my friends.
Fantastic writing; your passion for the topic is clear.
Your writing paints colorful pictures in my mind. I can envision every detail you portray.
Your blog articles brighten my day like sunbeams. I appreciate the positive energy you bring.
This write-up is a thorough guide on the topic; it’s a goldmine of information.
buy augmentin generic – how to buy ketoconazole duloxetine 20mg brand
vibra-tabs tablet – ventolin 4mg brand glucotrol us
order amoxiclav for sale – buy augmentin generic order cymbalta generic
rybelsus over the counter – rybelsus 14mg without prescription cyproheptadine over the counter
tizanidine 2mg cost – where to buy zanaflex without a prescription microzide over the counter
order tadalafil 10mg pill – buy viagra buy viagra 100mg pill
sildenafil citrate 50mg – buy cialis 40mg sale order tadalafil 40mg for sale
lipitor 10mg price – buy amlodipine online prinivil tablet
generic cenforce 50mg – buy generic cenforce buy metformin 1000mg
atorvastatin us – order lisinopril 5mg buy cheap lisinopril
Bayar4d link alternatif login dan daftar agen slot online resmi dan percaya
buy omeprazole 20mg generic – buy cheap generic tenormin tenormin price
buy cheap generic depo-medrol – oral aristocort 4mg triamcinolone online
clarinex pills – loratadine usa dapoxetine 60mg without prescription
buy generic cytotec over the counter – cheap diltiazem diltiazem price
order acyclovir 400mg online cheap – purchase acyclovir without prescription order crestor pill
motilium 10mg us – domperidone 10mg cheap buy flexeril 15mg without prescription
purchase motilium for sale – cyclobenzaprine 15mg us oral flexeril
inderal oral – clopidogrel 75mg pill buy methotrexate 2.5mg
coumadin usa – metoclopramide 10mg drug cozaar 50mg oral
order levofloxacin generic – levofloxacin 250mg without prescription order ranitidine
purchase nexium sale – order topamax 200mg pill imitrex pills
buy mobic without a prescription – tamsulosin 0.2mg drug cheap flomax 0.2mg
When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service? Bless you!
Feel free to surf to my web-site :: nordvpn coupons inspiresensation (http://t.co/gz5Gi0YSYB)
nordvpn coupon code 350fairfax
Excellent post. Keep posting such kind of information on your page.
Im really impressed by your blog.
Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely
digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.
ondansetron online buy – zocor 10mg cheap buy zocor 10mg generic
purchase valacyclovir online cheap – purchase valtrex online order diflucan 200mg without prescription
buy modafinil 100mg sale order modafinil 100mg pill provigil 200mg us buy generic modafinil 200mg order modafinil order provigil buy modafinil pills for sale
最新 の ダッチワイフ あなたがセックスドールについて考える必要がある現実ミニセックスドールVS大人のセックスドール、どのように選ぶか?コビッドとセックス人形についてのトップ5の驚くべき空想セックス人形とは何ですか?ダッチワイフ初心者向けマニュアル
More text pieces like this would create the web better.
Thanks an eye to sharing. It’s acme quality.
buy azithromycin online cheap – ofloxacin 200mg us flagyl 200mg brand
semaglutide 14mg without prescription – order semaglutide 14 mg pills order periactin generic
order domperidone 10mg sale – flexeril without prescription purchase cyclobenzaprine online
brand esomeprazole 40mg – https://anexamate.com/ buy nexium no prescription
coumadin price – coumamide.com how to buy cozaar
Awesome blog! Do you have any tips and hints
for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a
little lost on everything. Would you advise starting with
a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many
options out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas?
Thank you!
Feel free to surf to my web site :: eharmony special coupon code 2025
buy meloxicam 15mg generic – relieve pain mobic generic
Howdy I am so glad I found your blog, I really found you by accident,
while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here
now and would just like to say cheers for a remarkable post and a
all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time
to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added in your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.
Also visit my web-site; vpn
buy deltasone 10mg pills – https://apreplson.com/ deltasone 5mg cost
buy ed medications – fastedtotake.com medicine for erectile
order amoxicillin online cheap – buy amoxil tablets amoxicillin without prescription
oral fluconazole 200mg – https://gpdifluca.com/# fluconazole 200mg usa
brand cenforce – https://cenforcers.com/ buy cenforce 100mg pill
joy organics hemp gummies are a convenient and enjoyable motion to pocket cannabidiol without the high. Many people use them to affluence stress improve forty winks or promote complete wellness. The effects mainly inaugurate within 30–60 minutes and can matrix for respective hours. You’ll find options with melatonin vitamins vegan ingredients or no added sugar. They loosely transpire b emerge in a row of flavors and strengths. It’s most suitable to start with a low measure and always validate as regards third-party lab testing to insure rank and safety.