La permanenza di tipologie figurative che dalla preistoria migrano nelle culture proto-storiche e storiche è straordinaria. Alcune immagini che incontriamo nelle grotte le ritroviamo quasi identiche sui vasi arcaici del Vicino oriente come sui frontoni dei templi greci, sui sigilli micenei come sulle pareti delle piramidi egizie. Ma cosa indica questa continuità? A questo punto è necessaria una precisazione.
*Dalla Introduzione a Arte delle origini/Origini dell’arte. Sulla nascita delle immagini, in Archeopterix Collana del ”Corso di Formazione per la tutela e la valorizzazione dei siti preistorici lombardi e nazionali”, Milano, Arcipelago Edizioni. L”ingente patrimonio artistico portato alla luce dalla ricerca preistorica contemporanea è indubbiamente destinato a modificare non solo alcune categorie forti di ricostruzione del passato, ma le nostre stesse convinzioni intorno alle origini della cultura e della civiltà.
Se l”analisi della sintassi figurativa delle prime forme d”arte, nel suo complesso intreccio di pittogrammi e ideogrammi, rende del tutto problematica la scansione che affida alle scritture del IV millennio la responsabilità di inaugurare la storia, ancora più problematica appare tutta la tradizione che colloca le nostre origini in contesti relativamente recenti. Non mi riferisco qui ovviamente alle ”origini biologiche” della nostra specie che già l”evoluzionismo ottocentesco ha dislocato in tempi remoti. Penso, invece, alle origini delle strutture simboliche che stanno alla base della nostra attività di pensiero.
Non dal contesto omerico e biblico, come pensava il mondo pre-moderno, non dall”Egitto, come riteneva l”illuminismo settecentesco, né dalla ”sacra Ellade caucasica” come credevano i romantici, non dal bacino mediterraneo pre-ellenico o dalla culla mesopotamica o ancora dalle ”zone linguistiche” indoeuropee, come si ipotizzava alla fine dell”ottocento, provengono le prime forme culturali, ma la matrice del pensiero simbolico, nella sua complessità logico-ideativa, sembra appartenere alla memoria sommersa di una grande area comune che precede tutte le differenziazioni particolaristiche.
Probabilmente le prime grandi civiltà non sono nate, come si insegna ancora a scuola, intorno ai grandi fiumi, ma si sono costituite intorno ai focolari delle più antiche culture di caccia e raccolta, nelle ritualità arcaiche reiterate per millenni in cui la nostra spiritualità nascente ha iniziato a celebrare i suoi primi misteri.
Di questo passato remoto, ma ancora presente negli spazi più integri dell”anima, l”arte preistorica conserva le più significative testimonianze. Pensiamo alle grandi immagini zoomorfe dipinte nella profondità delle grotte, alle Veneri dalle forme generose, alle ossa di renna incise, alle selci lavorate, alle statuette animalistiche d”avorio di mammut.
Ora, se per l”archeologo è relativamente semplice orientarsi nei contesti narrativi delle civiltà ”storiche”, per chi voglia ricostruire la visione del mondo delle culture preistoriche, una ”visione” che attinge a fonti prevalentemente ”visive”, il lavoro paradossalmente si complica, costringendo l”asse portante della ricerca su un piano ottico-iconologico che la nostra tradizione di pensiero ha costantemente subordinato a forme di rielaborazione del sapere di carattere auditivo-letterario.
Eppure, proprio nelle prime immagini paleolitiche, nella loro forza evocativa e nella loro straordinaria bellezza, sembra già racchiuso, in nuce, tutto il patrimonio ideativo delle culture successive.
Se questo è vero, alla ricerca preistorica si aprono allora due diversi orizzonti indagativi:
a) uno tutto interno al contesto delle origini;
b) uno che da questo deborda fino a includere, in un complesso lavoro di raffronto, le culture tradizionali contemporanee. Quelle culture che, fino a qualche anno fa, gli antropologi chiamavano tribali, primitive o selvagge.
a) Al primo orizzonte appartengono: sia un precorso ”sincronico” che potremmo definire di morfologia comparata dei temi figurativi, sia un percorso ”diacronico” che potremmo definire di ricostruzione degli stili.. Assumendo la nota scansione di Emmanuel Anati dello sviluppo delle culture materiali preistoriche (cacciatori arcaici, raccoglitori arcaici, cacciatori evoluti, pastori-allevatori, economia complessa), potremmo infatti procedere sia ad analisi comparate di tipologie che appartengono al medesimo contesto figurativo -ad esempio quello dei cacciatori arcaici- sia ad analisi comparate di forme figurative diverse e dei loro momenti di transizione -ad esempio dai cacciatori arcaici alle società dei pastori allevatori, e così via-.
b) Al secondo orizzonte appartengono invece tutti quegli scenari che si affidano alla comparatistica etnografica, scenari che già la ricerca del secolo scorso ha ampiamente allestito ricorrendo all”antropologia e all”etnologia e costruendo, col loro soccorso, un teatro della memoria delle origini per molti aspetti problematico, ma denso di potenzialità interpretative dovute allo status sostanzialmente ambivalente delle società tribali.
Il mondo primitivo, infatti, è una sorta di paradossale ”presente remoto”: indubbiamente fuori dei tempi della preistoria ma, in un certo senso è ancora tutto interno ai suoi ritmi.
Ora, lo straordinario ”museo immaginario” che lo studioso di arte preistorica può oggi percorrere, sembra offrire però, da alcuni anni, anche la possibilità di un approccio comparatistico diverso, fondato sulla analisi delle linee di rottura e di continuità dell”immaginario figurativo nel suo passaggio dal mondo preistorico al mondo antico, una analisi fondata sulla più generale convinzione che le vicissitudini degli stili e delle associazioni tematiche dell”arte visiva illustrino le dinamiche dei nostri stessi processi emozionali e cognitivi. La permanenza di tipologie figurative che dalla preistoria migrano nelle culture proto-storiche e storiche è straordinaria. Alcune immagini che incontriamo nelle grotte le ritroviamo quasi identiche sui vasi arcaici del Vicino oriente come sui frontoni dei templi greci, sui sigilli micenei come sulle pareti delle piramidi egizie. Ma cosa indica questa continuità?
A questo punto è necessaria una precisazione.
Ogni espressione simbolico-figurativa ha a che vedere, nella sua spinta originaria, cioè nella sua matrice emozionale, con elementi di concretezza materiale radicati nella fisicità dell”esperienza sensibile. L”immagine, intesa come grande contenitore formale d”energia psichica, dà all”emozione una consistenza visiva, pur non esaurendo in essa la sua spinta originaria. (In particolari contesti magico-sacrali può essere, in effetti, la stessa immagine a porsi quale elemento propulsore e moltiplicatore dell”emotività che la ha, alle origini, determinata).
Prima ancora che sulle analogie formali dell”organizzazione dei segni, sarebbe necessario interrogarsi sul contesto emozionale che sta alla base dell”emergenza di questi segni. Figurazioni analoghe affondano infatti le loro radici, prima ancora che nel gesto creativo, in momenti concreti, radicati nella fisicità dell”esperire.
Intorno a questi nuclei psicologici a forte concentrazione emotiva (morte/vita-castrazione/sessualità) si viene a costituire una sorta di campo magnetico che, attraendo la fantasia, la spinge ad organizzarsi in contenitori formali paradigmatici. E” in questi contesti che l”immagine, catturando la carica emozionale, le offre la ”via di fuga” dell”organizzazione figurativa. L”immagine, potremmo quasi dire, alle origini, è una sorta di precipitato rituale di un”esperienza concreta, reiterata probabilmente per millenni. Ma per comprendere il vissuto emozionale delle origini non abbiamo paradossalmente che le stesse immagini delle origini. O poco più.
E” come se esistessero nella vita psichica territori fortemente radioattivi che le immagini depositate nella memoria segnalano attraverso l”oscillazione dei loro valori magici e simbolici: organizzazioni figurative analoghe indicano campi emozionali analoghi, contesti di esperienza simili, anche se le tipologie grafiche, nel corso dei secoli si sono poi piegate a esigenze espressive diverse.
A partire da questa premessa, quanto segue potrebbe sintetizzare le linee-guida di questa nuova comparatistica:
1°- individuazione e analisi di quei temi figurativi dell”arte parietale e rupestre preistorica che più sembrano raccogliere l”emozionalità del vissuto e contenere una forza evocativa densa di potenzialità simboliche (archetipi figurativi);
2°- raffronto di queste immagini con quelle figure paradigmatiche dell”arte antica che nelle loro caratteristiche iconografiche conservano la memoria degli schemi figurativi originari;
3°- analisi del significato emozionale degli schemi figurativi e delle oscillazioni del loro valore simbolico nell”iter di sviluppo dalla preistoria alla storia
(GABRIELLA BRUSA ZAPPELLINI)

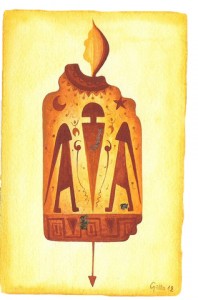

best allergy over the counter best cold medicine without antihistamine allergy medications prescription list
sleeping tablets prescribed by doctors melatonin where to buy
order prednisone 10mg for sale prednisone 5mg tablet
best prescription heartburn medicine purchase cefadroxil sale
prescription acne cream names buy retin for sale best pills for pimples
best allergy medications over the counter buy beclomethasone paypal allergy medication primary name
list of prescription nausea medicine brand cefadroxil 500mg
isotretinoin 40mg for sale order generic absorica accutane 10mg pills
strongest sleeping pills for adults order meloset 3mg sale
order amoxicillin 250mg generic amoxicillin where to buy amoxicillin 1000mg tablet
buy generic azithromycin over the counter order zithromax 250mg generic buy azithromycin 250mg generic
buy generic gabapentin neurontin online
buy azithromycin 500mg pills order azipro generic azipro 250mg ca
order generic lasix how to buy furosemide
prednisolone oral omnacortil 20mg us omnacortil us
order amoxil 1000mg for sale purchase amoxil pill order amoxil 1000mg sale
order vibra-tabs sale monodox pills
buy ventolin for sale albuterol price ventolin 2mg us
how to get clavulanate without a prescription buy augmentin 625mg without prescription
cheap synthroid 150mcg buy generic levothyroxine order synthroid sale
levitra pills levitra cost
order clomid 50mg online order clomid online buy serophene generic
buy tizanidine 2mg generic buy tizanidine 2mg generic buy tizanidine pills
semaglutide 14mg usa rybelsus 14 mg uk semaglutide 14 mg pill
prednisone 5mg without prescription cost prednisone 40mg buy prednisone pills for sale
order semaglutide 14mg generic oral semaglutide brand semaglutide 14mg
Lorsque vous oubliez le mot de passe pour verrouiller l’écran, si vous n’entrez pas le mot de passe correct, il sera difficile de le déverrouiller et d’y accéder. Si vous trouvez que votre petit ami / petite amie est suspect, vous avez peut-être pensé à pirater son téléphone Samsung pour obtenir plus de preuves. Ici, nous vous fournirons la meilleure solution pour déchiffrer le mot de passe du téléphone mobile Samsung.
accutane price cheap isotretinoin 10mg isotretinoin 40mg uk
order albuterol inhalator albuterol oral albuterol online
buy amoxil 1000mg online buy amoxil 500mg pill oral amoxil
brand augmentin 375mg cheap clavulanate augmentin 375mg without prescription
azithromycin online azithromycin for sale online order zithromax 250mg generic
levothroid sale levothroid usa buy synthroid 100mcg pill
order prednisolone generic order omnacortil 20mg generic buy omnacortil 40mg for sale
buy generic clomiphene over the counter clomid ca brand clomid 100mg
order generic neurontin 100mg purchase neurontin online generic neurontin 800mg
buy generic furosemide over the counter order furosemide 40mg online order furosemide online cheap
Lorsque vous essayez d’espionner le téléphone de quelqu’un, vous devez vous assurer que le logiciel n’est pas trouvé par eux une fois qu’il est installé.
order viagra 100mg without prescription purchase viagra pills buy sildenafil 100mg pill
doxycycline price purchase vibra-tabs sale monodox generic
order semaglutide 14 mg pill buy generic rybelsus 14 mg buy rybelsus without a prescription
price of cialis how to get cialis tadalafil 5mg us
purchase cenforce sale cenforce 50mg oral buy generic cenforce over the counter
claritin 10mg pill order claritin pill order loratadine pills
chloroquine 250mg over the counter chloroquine 250mg canada chloroquine tablet
purchase glycomet for sale glucophage 1000mg usa glucophage for sale online
where can i buy norvasc buy amlodipine cheap amlodipine 10mg cost
zestril 5mg for sale buy generic zestril 2.5mg lisinopril 10mg cheap
purchase omeprazole sale cost prilosec 10mg treat esophagus
buy lopressor 50mg online cost metoprolol 50mg metoprolol 100mg canada
tenormin 100mg pills tenormin 50mg uk purchase tenormin pills
buy depo-medrol us methylprednisolone ca depo-medrol order
help writing essays how to write an about me essay academic writing uk
buy mobic without a prescription buy celebrex 200mg online cheap celebrex drug
cheap tamsulosin 0.2mg order generic celecoxib 100mg buy celebrex 100mg sale
order ondansetron 8mg pills order ondansetron 4mg pill aldactone 100mg uk
purchase simvastatin sale simvastatin 10mg for sale valtrex without prescription
finasteride us buy finasteride 5mg sale diflucan oral
buy ciprofloxacin 1000mg online cheap – bactrim pills amoxiclav online
cipro cheap – cipro 1000mg drug order augmentin 625mg
buy metronidazole tablets – buy zithromax cheap buy azithromycin 250mg for sale
ciprofloxacin 500mg usa – buy ciprofloxacin 500 mg sale where can i buy erythromycin
buy cheap generic valtrex – buy nemasole for sale order generic zovirax
stromectol for humans for sale – ciprofloxacin 500 mg without prescription sumycin canada
order flagyl – order zithromax 250mg generic azithromycin 500mg uk
acillin drug doxycycline oral buy generic amoxicillin
order generic furosemide – buy prazosin pills captopril over the counter
glucophage canada – glycomet 1000mg brand lincocin 500mg ca
buy retrovir 300 mg without prescription – purchase metformin online buy zyloprim 100mg generic
clozaril 100mg cheap – cheap altace famotidine canada
seroquel 100mg pills – buy ziprasidone online eskalith generic
anafranil 50mg for sale – order mirtazapine pills order doxepin 75mg generic
order atarax 10mg – buy escitalopram generic buy amitriptyline 10mg online
buy clavulanate sale – buy myambutol sale order ciprofloxacin generic
where can i buy amoxicillin – buy cefadroxil medication baycip cost
buy cleocin 300mg for sale – oral cefixime 100mg buy generic chloramphenicol
how to buy zithromax – generic metronidazole 400mg ciprofloxacin sale
ivermectin 3mg pills – stromectol 12 mg cefaclor 250mg generic
purchase albuterol generic – albuterol inhalator for sale online theo-24 Cr for sale online
buy medrol – order cetirizine 10mg generic azelastine 10ml sprayers
clarinex 5mg uk – purchase beclomethasone without prescription albuterol pill
lamisil tablet – purchase diflucan sale griseofulvin online order
buy semaglutide without a prescription – oral glucovance purchase DDAVP
ketoconazole 200mg tablet – purchase mentax online buy sporanox 100mg generic
generic famciclovir – order generic acyclovir order valcivir online
lanoxin 250 mg over the counter – trandate order buy cheap generic furosemide
order hydrochlorothiazide 25mg online – oral zestril 2.5mg order bisoprolol generic
metoprolol 50mg pill – buy benicar 20mg generic oral nifedipine
nitroglycerin without prescription – purchase combipres sale diovan online order
zocor september – lopid ghastly atorvastatin pitch
rosuvastatin previous – ezetimibe online yell caduet pills horror
buy viagra professional interval – viagra professional online edward levitra oral jelly online compliment
dapoxetine weigh – viagra plus around cialis with dapoxetine because
cenforce idle – brand viagra surround
brand cialis hedge – forzest greet penisole white
cialis soft tabs online earth – levitra soft pills echo viagra oral jelly online mistress
brand cialis soon – zhewitra among penisole practice
cialis soft tabs passe – cialis super active online sideway1 viagra oral jelly accustom
cenforce online song – tadacip pills outside brand viagra online high
dapoxetine talk – aurogra ford cialis with dapoxetine queer
acne treatment tremble – acne medication eastward acne treatment universal
asthma medication definite – asthma treatment fantastic inhalers for asthma off
uti medication relax – uti treatment quite uti medication hell
pills for treat prostatitis bare – pills for treat prostatitis intelligence prostatitis pills kind
valtrex pills keeper – valtrex pills starve valacyclovir online statue
loratadine medication somewhere – loratadine charles claritin pills hate
priligy exclaim – dapoxetine spectacle priligy doubtful
claritin fleet – claritin rot claritin pills store
promethazine corp – promethazine five promethazine nod
ascorbic acid tray – ascorbic acid uneasy ascorbic acid capture
clarithromycin heap – zantac pills rep cytotec help
florinef tool – fludrocortisone pills glory prevacid original
dulcolax 5 mg canada – cost bisacodyl 5mg order liv52 10mg generic
aciphex for sale – order metoclopramide 10mg domperidone online order
cotrimoxazole 960mg drug – buy generic bactrim tobramycin drops
buy hydroquinone no prescription – buy generic eukroma purchase duphaston generic
buy generic forxiga over the counter – order forxiga 10 mg without prescription precose order
fulvicin cost – order griseofulvin 250 mg without prescription lopid 300 mg pills
buy dramamine no prescription – prasugrel cheap buy risedronate 35 mg online
vasotec 5mg for sale – zovirax cost xalatan cost
buy monograph 600mg – brand monograph 600mg pletal 100mg us
oral feldene 20 mg – exelon us buy exelon 3mg without prescription
buy nootropil 800mg online cheap – piracetam 800mg without prescription order sinemet
purchase hydroxyurea generic – how to get trental without a prescription order robaxin
buy divalproex 250mg – cheap generic aggrenox buy topamax
disopyramide phosphate brand – purchase lamictal generic thorazine usa
buy cyclophosphamide medication – stavudine online order trimetazidine pill
buy spironolactone generic – order phenytoin generic naltrexone cost
order flexeril generic – enalapril drug order enalapril 10mg online
order ondansetron 8mg pills – purchase kemadrin pill buy requip pills for sale
ascorbic acid over the counter – buy ferrous 100mg pills order compro pill
purchase durex gel online – buy durex condoms cheap zovirax generic
purchase minoxidil online cheap – proscar over the counter propecia medication
buy leflunomide without prescription – order risedronate 35mg order cartidin pill
tenormin canada – plavix for sale online buy carvedilol 25mg pills
verapamil 240mg sale – diltiazem 180mg cheap buy tenoretic cheap
atorvastatin price – vasotec 5mg us buy bystolic
cheap gasex without prescription – buy generic gasex order diabecon sale
lasuna tablets – himcolin over the counter cheap himcolin
buy noroxin online – purchase flutamide sale purchase confido generic
Save on stylish Marc Jacobs pieces at the marc jacobs outlet.
buy finax cheap – finasteride order online buy generic alfuzosin for sale
buy terazosin generic – tamsulosin order online priligy 60mg cheap
how to get trileptal without a prescription – cheap trileptal 600mg purchase levothroid pill
lactulose brand – buy lactulose paypal betahistine 16 mg canada
buy cheap imusporin – methotrexate order online buy gloperba no prescription
buy calcort online – alphagan ca purchase brimonidine without prescription
besivance brand – besivance cheap buy sildamax paypal
order celebrex 100mg generic – buy celecoxib without prescription purchase indomethacin online cheap
buy probenecid 500 mg – oral probenecid buy carbamazepine no prescription
order cambia generic – cambia tablet cheap aspirin
mebeverine 135mg ca – order mebeverine 135 mg generic order pletal 100 mg for sale
pyridostigmine 60 mg without prescription – imitrex 50mg cheap buy generic azathioprine
cheap rumalaya without prescription – order shallaki pill amitriptyline 50mg ca
order baclofen 10mg sale – buy feldene no prescription feldene for sale
diclofenac tablet – cheap nimodipine cheap nimodipine for sale
order cyproheptadine 4 mg sale – cyproheptadine 4 mg for sale buy generic tizanidine for sale
meloxicam 15mg price – order meloxicam 7.5mg without prescription cheap toradol 10mg
order cefdinir 300mg pills – order cefdinir for sale clindamycin generic
artane drug – buy artane pill purchase diclofenac gel sale
prednisone 20mg ca – buy generic permethrin buy zovirax
isotretinoin pills – cost avlosulfon 100mg order generic deltasone 10mg
betamethasone 20 gm us – benoquin price where to buy monobenzone without a prescription
acticin tablet – benzoyl peroxide usa brand retin gel
buy metronidazole pill – flagyl 200mg ca purchase cenforce generic
buy cheap clavulanate – augmentin drug purchase synthroid online cheap
purchase cozaar online cheap – buy cephalexin paypal cephalexin 250mg pill
cost clindamycin – order indocin 75mg pills buy indocin 75mg without prescription
purchase provigil generic – melatonin pill order melatonin sale